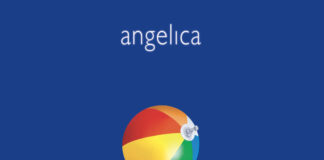I musicisti jazz dell’ultimo decennio hanno probabilmente un fattore in comune: esprimere in musica l’incertezza e la complessità dei tempi attraverso uno stile che attinga a tutto il repertorio del passato e che possa fungere da elemento descrittivo e catalizzatore dei temi musicali trattati. Una delle migliori espressioni di questo sentimento multiforme è il pianista di origini indiane (ma cresciuto e pienamente accentrato a New York) Vijay Iyer, che da anni ormai gode della considerazione altissima della critica mondiale, oltre ad aver vinto diversi referendum come miglior pianista o miglior disco dell’anno in molte blasonate riviste musicali; musicista non particolarmente esplosivo alla tastiera, ha saputo forgiare un personale stile jazzistico che ingloba la storia del genere afro-americano, costruendo un insieme di frammenti sonori che attingono a diverse fonti: il “Caravan” di Duke Ellington, l’obbliquità dei pianisti be-bop con un riferimento particolare a Thelonius Monk su cui spesso centra le sue evoluzioni, scampoli di free-jazz alla Cecil Taylor, tracce di modalità e di pianismo “creativo”, una basica presenza di elementi ritmici che richiama Steve Coleman e e le tematiche funk dell’M-Base; tutto ciò contribuisce a creare uno stile “discorsivo” che si nutre di continue evoluzioni allo strumento atte a formare increspature, che conferiscono al suono una certa cerebralità propria della musica contemporanea colta. La sua particolarità sta nell’uso di note o accordi ripetuti (che fanno pensare con le dovute distanze al minimalismo jazz di pianisti come Nik Bartsch) che riflettono un andamento immerso nell’attualità e sembrano voler riproporre in alcuni momenti suoni vicini al mondo dei computer e dell’elettronica (“Microchips and Bullock Carts” né un buon esempio).
Se con “Architextures” Iyer metteva già in mostra le sue doti e le sue influenze, è con l’album “Blood Sutra” che l’artista compie il salto qualitativo e raggiunge la maturità artistica, in virtù dell’energia e compatezza sprigionata dal suo quartetto in cui figura il suo fido sassofonista alto Rudresh Mahantappa, che conferisce lo spessore ideale per le composizioni di Iyer: gli album successivi “Reimagining”, “Tragicomic” e “Historicity” non fanno altro che accrescere la sensazione di trovarci di fronte ad un nuovo e complesso personaggio della musica jazz; Iyer si inserisce in quella stretta cerchia di pianisti avventurosi che sta tentando di dare un futuro al genere, cercando nel contempo una sufficiente originalità e profondità musicale: sebbene, allo stato attuale, la musica del pianista americano per molti non possa considerarsi ancora a livello dei suoi padri putativi, l’artista merita un grande rispetto per il contenuto tecnico apportato già al genere, espressione di una metodologia di approccio al jazz nettamente diverso dalla generalità dei pianisti attuali e passati; la collaborazione nel gruppo dei Fieldwork (che forse domani chiameremo supergruppo per via della partecipazione di valenti attori del presente come Steve Lehman e Tyshawn Sorey), nata per approfondire certi aspetti della concettualità jazz del passato, in una sorta di passaggio generazionale definitivo tra Coltrane e il presente artistico, dimostra come da musicisti/compositori come Iyer ci sia solo da imparare.
Discografia consigliata:
-Blood Sutra, Artist House, 2003
-Reimagining, Savoy Jazz 2005
-Tragicomic, Sunnyside R. 2008
-Historicity, Act 2009
-Door, con i Fieldworks, Pi-Recordings, 2008