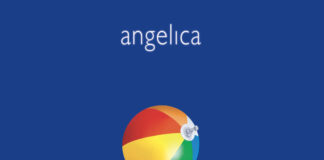I Soft Machine meritano un posto migliore di quello che la storiografia rock e jazz gli ha attribuito. La loro importanza, contestualizzata nel periodo di maggior fervore della musica, sta non solo nell’aver contribuito alle prime ed embrionali forme di matrimonio fra la musica rock e il jazz, ma soprattutto sta nel fatto di aver gettato un ponte di raccordo sulle possibili strade che la musica in generale stava intraprendendo. Il gruppo principe di Canterbury, grazie alle sue individualità, riusciva a condensare in una originale formula musicale il progetto di una musica intensa, intellettuale, vera e filosofica allo stesso tempo, che univa correnti letterarie, movimenti scientifici, le spirali moderne delle avanguardie della musica classica (segnatamente il minimalismo), il jazz di Davis e Coltrane. Le biografie sul gruppo e sugli elementi che vi hanno transitato sono diventate oramai numerose e sempre piene di particolari ma spesso sono lacunose sul versante delle peculiarità artistiche che si svilupparono all’interno del gruppo. Verrebbe da pensare ad un ragguardevole progetto istituito per unire pezzi diversi ed estrazioni musicali eterogenee, tanto sono visibili le caratterizzazioni che ogni singolo musicista presentava nel contesto delle composizioni. Così come oggi la critica pone ensembles come i Pink Floyd al vertice di un certo tipo di aggregazioni musicali, così sarebbe opportuno rivalutare le evidenze dei Soft Machine come somma di parti costruite sulla conoscenza e la volontà di raggiungere punti di contatto tra mondi musicali diversi.
Robert Wyatt viene da sempre considerato il capostipite storico del gruppo, soprattutto nei primi due episodi, dove è visibile il suo approccio stilistico: Wyatt condensava in un suo magnifico linguaggio di fonemi un puzzle musicale che si componeva di vari elementi; in lui si maturò un tentativo di raggiungere un’unità linguistica universale, qualcosa che troverà sublimazione musicale nella carriera solistica e in alcuni albums di alto livello, tra cui impossibile non citare Rock Bottom; la psichedelia acida di Hendrix e il jazz di Bitches Brew erano pretesti, in realtà Wyatt si adoperava per delineare un lato apparentemente nonsense ma che era in grado di portarti nei meandri degli argomenti della patafisica e del mondo “ragionato” dell’immaginazione.
Se il primo album dei Soft Machine rimane ancora oggi un oggetto confuso e poco focalizzato, il secondo è una delle sue più compiute espressioni: accorgimenti sui distorsori, improvvisazioni strumentali sontuose, la voce dada di Wyatt e i rimandi psichedelici dei suoni, gli arrangiamenti e legamenti perfetti tra i brani, tutto è indimenticabile in questo disco. In Third, quattro suite di musica jazz-rock godibilissima, Wyatt limita il suo apporto a Moon in June, raggiungendo il massimo punto di intersezione fra la sua tematica e quella del gruppo. Le differenze stilistiche con gli altri membri erano chiarissime, così come è un grosso errore di valutazione pensare che il vero sound dei Soft sia concentrato nei primi tre episodi: se realmente oggi volessimo attribuire un marchio di fabbrica ai Soft non si potrebbe fare a meno di pensare a quell'”organetto” usato da Mike Ratledge e che ha accompagnato il suono del gruppo almeno fino a Six. Ratledge si inventò una sorta di suono free eterogeneo che sembra seguire paesaggi fiabeschi (come in molti gruppi di Canterbury), che incorpora le voci anonime degli gnomi, della natura e di personaggi da Alice nel paese delle meraviglie: un organo fanciullesco, ma terribilmente serio dal punto di vista musicale. Il lavoro di Ratledge è basilare e in Third costituirà l’apporto fondamentale, con una valenza musicale ed una malleabilità osmotica con gli altri musicisti che definire solo come collante del gruppo sembra essere riduttivo: autentico crocevia stilistico, in Third verrà alla ribalta il lato più strettamente jazzistico dei Soft, grazie all’entrata e alle qualità del sassofonista Elton Dean, che parteciperà a tre albums del gruppo, prima di dedicarsi alla carriera solista e a progetti incrociati. Dean, scomparso recentemente, fu colui che portò il gruppo più vicino al jazz, molto di più di quanto facevano gli altri: se Wyatt e Ratledge risultavano musicisti di raccordo (in Third si ascoltano “gambe” psichedeliche, timbriche di suoni sparsi in senso avantgarde, passaggi minimali alla Riley), Dean era un puro jazzista, con una capacità di creazione improvvisativa che spesso sembrava essere avulsa dal contesto del brano: nella migliore tradizione del british jazz di quegli anni, risultava essere melodico e parkeriano allo stesso tempo.
Se il primo album dei Soft Machine rimane ancora oggi un oggetto confuso e poco focalizzato, il secondo è una delle sue più compiute espressioni: accorgimenti sui distorsori, improvvisazioni strumentali sontuose, la voce dada di Wyatt e i rimandi psichedelici dei suoni, gli arrangiamenti e legamenti perfetti tra i brani, tutto è indimenticabile in questo disco. In Third, quattro suite di musica jazz-rock godibilissima, Wyatt limita il suo apporto a Moon in June, raggiungendo il massimo punto di intersezione fra la sua tematica e quella del gruppo. Le differenze stilistiche con gli altri membri erano chiarissime, così come è un grosso errore di valutazione pensare che il vero sound dei Soft sia concentrato nei primi tre episodi: se realmente oggi volessimo attribuire un marchio di fabbrica ai Soft non si potrebbe fare a meno di pensare a quell'”organetto” usato da Mike Ratledge e che ha accompagnato il suono del gruppo almeno fino a Six. Ratledge si inventò una sorta di suono free eterogeneo che sembra seguire paesaggi fiabeschi (come in molti gruppi di Canterbury), che incorpora le voci anonime degli gnomi, della natura e di personaggi da Alice nel paese delle meraviglie: un organo fanciullesco, ma terribilmente serio dal punto di vista musicale. Il lavoro di Ratledge è basilare e in Third costituirà l’apporto fondamentale, con una valenza musicale ed una malleabilità osmotica con gli altri musicisti che definire solo come collante del gruppo sembra essere riduttivo: autentico crocevia stilistico, in Third verrà alla ribalta il lato più strettamente jazzistico dei Soft, grazie all’entrata e alle qualità del sassofonista Elton Dean, che parteciperà a tre albums del gruppo, prima di dedicarsi alla carriera solista e a progetti incrociati. Dean, scomparso recentemente, fu colui che portò il gruppo più vicino al jazz, molto di più di quanto facevano gli altri: se Wyatt e Ratledge risultavano musicisti di raccordo (in Third si ascoltano “gambe” psichedeliche, timbriche di suoni sparsi in senso avantgarde, passaggi minimali alla Riley), Dean era un puro jazzista, con una capacità di creazione improvvisativa che spesso sembrava essere avulsa dal contesto del brano: nella migliore tradizione del british jazz di quegli anni, risultava essere melodico e parkeriano allo stesso tempo.
Hugh Hopper, il bassista scomparso del gruppo, invece, era l’elemento propulsore del gruppo: molta critica gli ha attribuito un posto fondamentale nei Soft, tuttavia Hopper, forse sarà ricordato più per i suoi esperimenti solisti e solo indirettamente per aver prestato il suo basso nel gruppo: nella mia memoria rimane il suo primo ed ineguagliabile disco del 1973 intitolato 1984, che mostrava, oltre al bravo musicista, una forte figura compositiva che si dimenava nel tentativo di creare un trade d’union fra Canterbury e le evoluzioni elettroniche che la musica classica stava coltivando in quel periodo. In quel disco fu aiutato molto da un altro sassofonista, di cui nessuno mai ne parla, Gary Windo, un talento immane in possesso di un timbro personalissimo, drammatico e free al tempo stesso, una figura che impreziosì anche il Rock Bottom di Wyatt.
Con Seven e la sostituzione di Ratledge con Karl Jenkins, il gruppo riceverà la sua terza dimensione: dopo quella iniziale, psichedelica e patafisica guidata da Wyatt, quella intermedia, più orientata al jazz e alla musica colta iniziata con Third e con l’entrata di Dean, ci sarà la fase Jenkins, che porterà il gruppo nei meandri di una fusion di classe, a tratti costruita su assoli di alto livello, ma forse senza quella magia che caratterizzava i lavori del gruppo. Tuttavia Jenkins (che avrà modo di raggiungere il suo zenith artistico-commerciale con gli episodi di Adiemus e con l’entrata in pieno stile classico inglese nella musica corale e orchestrale), dimostrava di avere una visione differente del progetto: molti fans dei Soft ritengono che sia stato lui a provocare il defilarsi del gruppo e del suo scioglimento, ma in realtà Jenkins cercava di guadagnarsi anch’egli un posto di rilievo nell’ambito del progetto Soft Machine: sebbene la sua formazione fosse nettamente improntata ad un jazz-rock convenzionale, Jenkins cercava di portare alla sua maniera elementi della scrittura classica per suscitare nell’ascoltatore un perfetto traghettamento dai suoni originali del gruppo a qualcosa che comprendesse anche elementi del suo bagaglio artistico, e sicuramente episodi come Bundles o Softs (che mostrano ganci in un un suono più estatico) testimoniano come l’inglese cercasse comunque un rinnovamento che potesse liberare il gruppo da un suono tipico di cui ossessivamente se ne era rimasti intrappolati. Ed era sicuramente un compito non facile.
Discografia consigliata:
-Volume Two, Probe 1969
-Third, CBS 1970
-Fourth, CBS 1971
-Fifth, CBS 1972
-Six, CBS 1973
-Seven, CBS 1973
-Bundles, Harvest 1975
-Softs, Harvest 1976