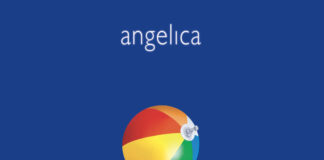Uno dei desideri forti di molti europei è spesso quello di americanizzarsi dal punto di vista musicale. Joe Jackson rappresenta uno degli esempi compiuti di questo processo di americanizzazione che in verità è un fenomeno che spesso si incrocia con il suo opposto. Jackson, alla fine degli anni settanta, era un giovane leader di un gruppo rock, che suonava più “Usa” che “England” (cioè la terra di provenienza): in quegli anni, assieme a gente come Elvis Costello, Nick Lowe, Graham Parker, etc., fu portavoce di un movimento musicale che pur partendo dalla provincia inglese, aveva metabolizzato tutti i caratteri somatici musicali dei generi americani: il puzzle era composito e comprendeva una base punk, memore della lezione rock’n’roll di Chuck Berry, in cui venivano introdotti elementi di moda dell’epoca come la ska music e il raggae, filtrando il tutto con la sensibilità pop dell’Inghilterra dei Beatles. I primi tre albums di Jackson sono pienamente immersi nello stile pub-rock e introducono un artista diretto, forse ancora acerbo dal punto di vista compositivo, le cui canzoni, brevi e alla ricerca di un immediato riscontro, non dispongono ancora di quella personalità che arriverà in seguito. In realtà, già con il terzo Beat Crazy Jackson fa un passo in avanti; se i primi due si proiettavano senza particolari sussulti in una giostra di suoni eterogenei alla moda, Beat Crazy comincia ad evidenziare un miglioramento notevole della scrittura (che acquisisce più originalità grazie ad una maggiore variazione dei temi), un miglioramento vocale raggiunto grazie ad una maggiore duttilità della ricerca musicale (con una gamma “fanciullesca” che va dallo sbarazzino e ribelle fino al falsetto malinconico e drammatico) e matura l’idea di una confluenza musicale, una miscela di suoni diversi, esaltati dinamicamente, una formula che costituirà il leit-motiv della sua carriera.
L’episodio di Jumpin’ Jive, in cui Jackson si rivela appassionato del jazz ante modernità, lo introduce al secondo stadio della sua carriera, quella che gli ha dato sicuramente maggiori soddisfazioni commerciali: così come fu partecipe del movimento pub, allo stesso modo Jackson si rende protagonista del nascente filone new cool jazz che sboccia in Inghilterra negli anni ottanta e che vede nelle sue fila artisti come gli Style Councils di Paul Weller e Mick Talbot, gli Everything but the girl di Tracey Thorn e Ben Watt, i Working Week, la poderosa Carmel, etc. Lo scopo intrinseco di questa corrente è riproporre certi temi melodici del jazz degli anni quaranta e cinquanta, quelli vicini alle escursioni musicali di Mulligan e Baker, o a quelle di Rollins e Webster, rivisti però secondo un gusto moderno ed un proprio stile: Joe lo fa capire chiaramente nella copertina di Body and soul un disco in cui Jackson viene raffigurato in un atteggiamento simile a quello dell’album Volume 2 di Sonny Rollins; Jackson, in quel periodo, viene invitato a suonare dal produttore Hal Willner nel tributo a Thelonious Monk, dove restituisce una delle più belle versioni di Round Midnight, pezzo celeberrimo nel jazz scritto dal grande pianista americano.
Negli albums a suo nome Joe consegnerà alcuni capolavori di sintesi tra sensibilità jazz, ballate pop, blues, musica latina, pub-rock, che si faranno apprezzare anche per l’aspetto tematico: in tal senso va valutato l’ottimo Night and Day pubblicato nel 1982, che si ispira agli umori musicali della New York di quegli anni, ne è un sunto aggiornato visto con gli occhi di un ipotetico cittadino europeo che va a vivere nella Grande Mela, un viaggio ricco di spunti che inducono anche ad una intelligente riflessione umana. Con un arrangiamento indovinato, Night and Day contiene novità sul versante percussivo e molti espedienti sui sintetizzatori e su una drum machine che marca a fuoco Steppin’ Out, una delle sue canzoni più famose.
L’attrazione di Jackson per la musica classica si rivela completamente in Will Power, dove si misura il polso delle ambizioni dell’artista. Forgia un suo suono che si insinua tra il generale polistilismo stilistico che lo contraddistingue e nei suoi cinque brani che lo compongono distilla un suo stile dinamico e fantasioso al servizio di accattivanti brani che pescano dal minimalismo (americano), dalle sinfonie particolarmente avvezze ai violini di stampo Barberiano (ancora americani), dal pianismo jazz diviso tra scuola europea di fine ottocento e tempi tipicamenti Gershwin-iani (sempre americani); Jackson, che aveva studiato composizione alla Royal Accademy of Music di Londra, mostra un talento ineccepibile per un artista che proviene dal rock anche se naturalmente si mantiene nei confini della tonalità; restando in quell’ambito, la sua musica potrebbe essere persino rivalutata perché non è certamente deteriore rispetto ai livelli dei percorsi rock e jazz. Will Power può entrare con diritto tra i migliori dischi del movimento classico new-romantic dell’epoca, lo si può tranquillamente accostare pur non essendoci segnalazioni della critica in tal senso.
Un altro album controverso sarà anche Heaven and Hell del 1997, in cui Jackson tenta di dar luogo ad una idea omnicomprensiva al pari di Night and day: l’approccio cosmopolita resta, laddove in Heaven and Hell però si coniuga con toni classici (specie barocchi e neoclassici), elementi di lounge music e new age (per via di piano e battute programmate in loop), scrittura pop, beat’n’drums; il risultato è di ottimo spessore e l’idea di rappresentare attraverso delle songs cycle i sette vizi capitali è frutto anche del prezioso intervento di molte star canore (Dawn Upshaw, Joy Askew, Jane Siberry, Suzanne Vega), sebbene forse balena l’impressione che risulti alla fine un pò vittima di quel crogiuolo di stili così diversi. Heaven and Hell sta al modernismo come Will Power stava al classicismo. A dispetto del titolo, Symphony n.1, due anni dopo, è una sinfonia che fa parte più del jazz che del mondo classico.
Jackson oggi vive a Berlino e sembra abbia un pò ripudiato filosoficamente l’ambiente newyorchese post-novanta.