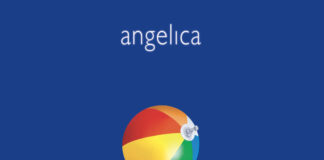Una delle più controverse realizzazioni di successo della musica jazz appartiene alla famiglia Marsalis: i due fratelli Wynton e Branford, riconosciuti spesso come jazzisti di spessore, hanno sempre diviso pubblico e critica in virtù di una semplice prerogativa comune a tanti altri musicisti: la voluta accondiscendenza agli stilemi del passato e la totale abnegazione per quelli futuri; ma qui il problema era diverso, poichè si trattava di musicisti con le più alte qualificazioni tecniche mai sperimentate. Il trombettista Wynton Marsalis viene ancora oggi liquidato come una controfigura di Miles Davis o anche come un trombettista di valore ma senz’anima; il sassofonista Branford Marsalis viene molto trascurato per via della somiglianza sonora a Coltrane e ha dovuto attendere anni per poter dare una svolta concreta alla sua carriera; gli altri fratelli musicisti (Jason e Delfeayo) sono praticamente ignorati, anche da parte di molti addetti ai lavori.
In realtà le cose vanno lette un pò diversamente: mettendo anche da parte la formazione musicale dei due fratelli in questione (che si basa sull’esplorazione di molto repertorio classico anche risalente al periodo barocco) c’è da sottolineare come gli stessi abbiano sostanzialmente portato a livelli di perfezione formale i loro strumenti invero caratterizzando per certi versi le loro produzioni musicali.
Wynton, soprattutto, si può considerare dal punto di vista tecnico, la migliore espressione della tromba mai vissuta nella storia del jazz, e se è indubbio che lo stesso fosse filiazione di trombettisti già sperimentati (specie nel sound di New Orleans e nel be-bop) è anche vero che nessuno è riuscito a dare alla tromba un livello di perfezione tecnica così alto: estensione di registro e timbrica, facilità di movimento e di passaggio da toni alti a quelli bassi, precisione e chiarezza nell’arrivare sulle note, fanno di lui il probabile punto d’arrivo dei trombettisti di una intera generazione di jazzisti. Ma il jazz come inteso da Wynton è solo quello che scaturisce dalla “tradizione” e non è possibile scomettere su nient’altro che non sia il jazz così come da lui riconosciuto: se l’aver accantonato a priori lo sviluppo della tromba moderna può essere un peccato grave, è anche vero che non si può condannare un musicista che suona a quei livelli: quello di Wynton è un atteggiamento da virtuosi, che a dire il vero trova ancora una sua motivazione d’essere e un suo spessore (gli attacchi e il venir via dei fiati New Orleans, il feeling creato da un blues sound di antica ispirazione e con molti riferimenti a quello orchestrale di Duke Ellington). E’ in questa contraddizione si gioca tutto il personaggio: la carriera iniziata subito in grande stile avrà un sussulto nei dischi dove non si limiterà ad aggiornare e a dare versioni “definitive” di standards, ma in quei lavori dove le composizioni sono a suo nome: tra tutti spicca lo splendido “Black Codes” che rappresenta il tentativo di coniugare tecnica ed emozioni, nonchè il lungo sermone musicale di “The majesty of the blues”, l’episodio artisticamente più variegato della sua carriera, al limite di quella gabbia stilistica da lui richiamata.
Wynton è stato spesso al centro di polemiche per via delle sue opinioni sulla musica ed in particolare fu attaccato per la freddezza del suo jazz: Keith Jarrett lo criticò aspramente per via anche della composizione scarna, salvo poi affrontare una lunga parte della sua carriera (ancora oggi presente) imperniata sullo standard. Così come in “From the Plantations to the Penitentiary” Wynton critica ferocemente gli sviluppi della storia della sua razza che, dopo aver raggiunto uno status culturale frutto di tante battaglie sociali, si è lasciata trasportare da mode (musicali) effimere e denigrative. Ma invero quei caratteri di negatività si riscontravano anche nei bianchi e nella loro musica.
Wynton poi ha cercato anche di dare una dimensione “classica” al suo modo di organizzare il vecchio buon jazz, cercando di estendere l’uso dei fiati assieme ad un’orchestrazione di tutto punto, riproponendo la formula Ellington-Evans in tempi moderni: se i tanti episodi in tal senso non gli garantiranno certo una certa popolarità (“Blood on the fields” che vincerà il premio Pulitzer, primo disco di jazz a vincere in una gara di scontata prevalenza classica cadrà nel dimenticatoio) , una serie di incursioni più “leggere” hanno tentato di bilanciare la sua serietà espressiva. “W.Marsalis e E.Clapton play the blues live from Jazz at Lincoln Center” fa parte di quest’ultime registrazioni, in un ambito di serio anonimato.
Branford, che era il braccio destro di Wynton, nella prima parte della sua carriera, faceva fatica a trovare un suo stile, finchè nei novanta, grazie all’inserimento di un piano evocativamente classico e un suono di sax dal risvolto barocco (cosa che impreziosirà il miglior disco di Sting “The dream of the blue turtles”) ne trova uno più personale: più robusto, muscoloso ed etereo a seconda dei casi, Branford si emancipa parzialmente da Coltrane per elargire assoli di elevato spessore artistico seppur riconducibili ad una formula jazzistica ben consolidata: da “The beautyful ones are not yet born” l’artista di New Orleans crebbe di spessore, lasciò anche il gruppo del fratello maggiore lanciandosi anche in iniziative poco jazzistiche (le registrazioni hip-hop con il dj Buckshot le Fonque, il trio rock-funk di “Dark Keys”); ma lo faceva caratterizzando il suono. L’espansione artistica di Branford trova pieno compimento nel decennio passato con l’entrata al piano di Joey Calderazzo che conferisce il quantum “classico” voluto: “Eternal” è l’espressione massima del sassofonista che riesce, accanto ad una scrittura jazzistica di raffinato valore tecnico, a produrre in maniera mirabile quell’esaltazione del suono lento da “ballad” che spesso tanti musicisti hanno provato nella loro carriera senza potergli dare una giusta definizione (forse nemmeno Coltrane). Il disco con Calderazzo “Songs of mirth and melancholy” riprende questo concetto, (dopo un paio di registrazioni più “muscolose”), fornendo anche una “nuova” versione di Eternal; l’ideale connubio tra classicità della musica e “feeling” del jazz viene così riaffermato.
Dischi consigliati:
Wynton Marsalis:
-Black Codes, 1985
-J Mood, 1986
-The majesty of the blues, 1989
-Blue Interlude, CBS 1992
-City Movement, 1992
-In this house on this morning, 1994
-Blood on the fields, 1997
Branford Marsalis:
Crazy People Music, Columbia 1990
The Beautyful Ones Are Not Yet Born, 1991
Requiem, Sony 1996
Contemporary jazz, Columbia, 2000
Eternal, Rounder, 2004