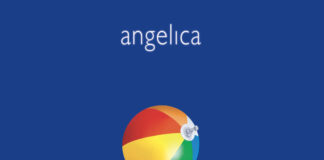Il vibrafono nel jazz ha avuto un padre putativo per ogni genere che si è succeduto: il pioneristico Lionel Hampton nell’era swing, Milt Jackson, cerniera tra il be-bop e il cool anche attraverso il Modern Jazz Quartet, Bobbie Hutcherson, raccordo tra hard-bop e free jazz, Gary Burton nella fusion, Cal Tjader nella latinità. Strumento molto sottovalutato e che spesso veniva affrontato dai musicisti casualmente, il vibrafono era l’unico strumento tra le percussioni che ben si adattava alle fondamenta musicali del jazz, dandogli un candore che prima fu ritmico e poi più propriamente musicale. Negli ultimi anni la ricerca di vibrafonisti con caratteristiche di modernità sembra contare poche individualità, poichè la gran parte di essi continua a rimescolare il passato e non sempre con personalità; tuttavia qualcuno, grazie all’apporto dell’elettronica e allo sfruttamento delle risonanze, cerca di creare innovazione. Metto insieme in questo articolo tre casi odierni attraverso l’ascolto delle loro ultime prove discografiche: Jason Adasiewicz, Stefon Harris e Matthias Lupri.
Jason Adasiewicz è di Chicago, è nato nella scena post-rock di quell’area, e dimostra di avere una naturale tendenza verso esperienze di impronta ibrida tra una verve boppistica e una piena libertà di stile: dopo un valido esordio con il gruppo dei Rolldown, Adasiewicz è stato ospite fisso praticamente di tutta la nuova scena jazz di Chicago che conta, suonando assieme a Rob Mazurek e alla sua creazione orchestrale (la Exploding Star Orchestra), nei gruppi di Mike Reed, Nicole Mitchell e Ken Vandemark (Jazz Chicago Style), sviluppando quindi anche un profondo senso di attaccamento a tematiche “free” jazz. Poi, qualche anno fa con “Sun Rooms” è arrivato un pieno affrancamento delle sue capacità e idee, che in “Spacer” ha trovato conferma: l’orizzonte è piuttosto variegato e si pone stilisticamente molto vicino alla poliedricità di genere di Hutcherson, sebbene in alcuni momenti Adasiewicz dimostri una sua personalissima visione dello strumento, tesa a ricreare sonorità sospese in una timbricità eterea e quasi esotica.
Stefon Harris è considerato il miglior vibrafonista della sua generazione e certamente il fatto di essere stato scritturato fin da inizio carriera dalla Blue Note è stato un viatico per incrementare la sua popolarità: tuttavia la stessa non ha mai espresso episodi eclatanti: Harris è un’asso nella tecnica (in alcuni momenti sembra una duplicazione del piano) ma è anche un’espressione del tempo che fu. Un buon modo di ascoltarlo può essere la raccolta di songs “Ninety miles” effettuata con il sassofonista David Sanchez e il trombettista Christian Scott, dove compaiono anche alcune tra le migliori composizioni dell’americano, che trovano in questa versione forse una migliore riesposizione.
Matthias Lupri è invece il più incline alla tecnologia: oltre ad usare un vibrafono elettrico, si caratterizza per il fatto di suonare spesso oltre che con i battenti, anche con risonatori di suono (usa gli archi del violoncello colpendo delicatamente la parte inferiore dello strumento per creare l’effetto): quello dello sviluppo degli armonici è il prossimo campo di battaglia dei vibrafonisti, coltivato nella musica colta da compositori come Christopher Deane. Lupri, tedesco naturalizzato canadese, pubblica per la Summit Records un’antologia ben calibrata, che evidenzia le esperienze fatte con una serie di musicisti importanti tra i quali quella con i gruppi di Mark Turner e Cuong Vu, con Kurt Rosenwinkel e con Myron Walden e Danny McCaslin. “After hours, Moonlamps and other ballads” può essere un giusto compendio per chi non ha ascoltato “Transition sonic” e “Metalix”, opere innovative che accanto a valide rielaborazioni del mainstream producono anche interessanti evoluzioni ipnotiche del vibrafono.