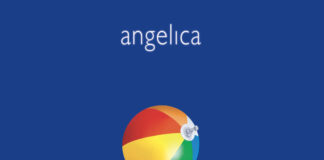Nel jazz il processo di avvicinamento alla musica classica è stata situazione che ha diviso stampa ed appassionati: se inizialmente l’integrazione tra strutture diverse fu accolta come una nuova panacea, successivamente l’assorbimento di elementi sempre più dissonanti e atonali da entrambe le parti, avevano di fatto creato un proibizionismo dell’ascolto che comprometteva il suo allargamento tra i fruitori. Le cose, poi, si complicarono quando il free jazz cominciò a prendere come obiettivi i risultati più estremi delle avanguardie musicali, specie quando a New York si impose la figura di John Zorn. I sassofonisti erano i protagonisti di questi cambiamenti epocali: le esperienze di Coltrane ed Ayler da una parte rappresentavano (per molti) ancora un baluardo interpretativo difficile da superare e che apparteneva forse agli sviluppi di un jazz primordiale, mentre Braxton e Mitchell invece avevano già compiuto le loro integrazioni creative con le filosofie musicali di Cage o Stockhausen; in Europa Evan Parker, Brotzmann e tanti altri erano i detentori della radicalità: i sassofonisti al tenore alla fine degli anni ottanta si trovavano di fronte quindi ad un bivio, quelli che ritenevano che la ricerca fosse finita e che si ponevano come dei meri epigoni tendenti a sviscerare note ed emotività di cui vi era già una forte traccia storica (anche quando realizzata con ferocia strumentale) e dall’altra quelli che conducevano improbabili e rischiose sperimentazioni con il mondo contemporaneo nutrito non solo dagli insegnamenti dei principali compositori di riferimento, ma anche da tutto quel substrato di teorie tecniche che cercavano nell’aggressione dello strumento un punto di continuazione storica; lo scopo era mirare alla trasformazione della “voce” del sassofono di fronte anche alla scoperta di utilità “celate” dentro (compreso il rumore) e fuori lo strumento (lo studio delle pause e dei silenzi). Tradotto in termini brevi, questo significava che il livello tecnico dei sassofonisti doveva innalzarsi in maniera decisa e la conseguenza di tale innalzamento era che i sassofonisti più preparati (certamente in numero sempre più ridotto) erano sempre più lontani dai gusti del pubblico. La realtà fu che si creò, quasi spontaneamente, tutta una impalcatura che vedeva il sassofonista free jazz farsi affiancare da una strumentazione da camera (quand’anche orchestrale) in un gioco che tendeva a coniugare improvvisazione jazzistica libera e le regole di composizione dettate dalle discipline classiche (contemporanee) con la scelta da parte dei musicisti di affrontare situazioni di radicalità espressiva più o meno pericolose ai fini dei risultati da raggiungere.
La decisione di scrivere un extended-post (quattro parti) per lui deriva dalla inaspettata e incredibile conoscenza epistolare con l’artista, che mi ha inconsciamente trasportato verso un implicito patto di amicizia: Ivo mi ha consegnato la sua musica e la sua arte, io gli consegno i miei pensieri e la mia sensibilità.