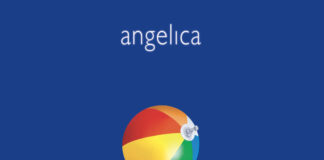Per mantenere in salute il jazz probabilmente non c’è altro rimedio che mantenere alta la creatività: se siamo cinici e non ipocriti nel valutare il punto a cui oggi siamo giunti, noi dovremmo affermare che alla fine quello che conta è la combinazione dei suoni; la storia del genere è stata costellata da musicisti che hanno mostrato quelle intuizioni che prima o poi qualcuno avrebbe tirato fuori: chiamiamo iniziatori i fortunati che sono nati al tempo giusto nel posto giusto (Ellington, Armstrong, Parker, Monk, Coltrane etc.). Però a differenza di quello che si può pensare esistono ancora delle differenze che permettono di focalizzare il reale contenuto innovativo delle proposte ed impostare delle riflessioni; come da sempre affermato in questo blog oggi bisogna far riferimento a due mondi, quello della novità assoluta (qualora questa arrivi) e quello dell’espressività di una proposta con contenuti innovativi nel processo.
Qui parlo di tre giovani piano players statunitensi particolarmente interessanti che potrebbero essere punti di riferimento del panorama jazzistico internazionale del domani: si tratta di Kris Davis, di Matt Mitchell e Aaron Parks, che prendo in esame attraverso le loro primissime elucubrazioni allo strumento.
Kris Davis (1980) canadese di origini, è stata definita dalla stampa specializzata come pianista caleidoscopica dotata di una preparazione impeccabile; come la sua collega Angelica Sanchez, Kris appartiene al giro dei jazzisti canadesi residenti a New York ed ha un impronta di base molto votata all’improvvisazione free di Tayloriana memoria ma sarebbe un madornale errore non pensare ad una forma evoluta di pianismo jazz post-Taylor. La Davis ha pubblicato già diverse raccolte discografiche tra cui le più importanti sono quelle in cui suona quasi pedissequamente nella formazione in quartetto assieme al sassofonista Tony Malaby, al contrabbassista Eivind Opsvik e il batterista Jeff Davis (tra le quali vi segnalo “Rye Eclipse“) e quelle più recenti in trio con la Laubrock e Sorey; tuttavia è nella sua dimensione intima che si scorge l’originalità della musicista: “Aeriol Piano” pubblicato dalla Clean Feed nel 2011, la vede affrontare a seconda dei casi classicità jazz e sperimentazione pianistica: l’ottimo rifacimento dello standard di Jerome Kerns “All the things you are” è un episodio che induce all’errore l’ascoltatore che non continua l’ascolto: la Davis intraprende in realtà viaggi diversi grazie ad un utilizzo estensivo del pianoforte: si tratta di mettere assieme le istanze ruminative di Taylor con accordi atonali aerei (quasi ambientali) e pizzicati di corde all’interno del piano, di proiettare il suo jazz cittadino (ossia quello che potrebbe accompagnare le azioni di tutti i giorni dell’uomo) in suoni animosi e spasmodici ricavati da piano preparato, ottenendo pluralità di riscontri evocativi (Feldman, Berio, Ligeti) in base agli argomenti sviluppati. Quello che colpisce è la fantasia combinatoria della pianista che costruisce una formula di jazz modernissimo che sembra parlare da sè tant’è chiara e discorsiva nell’espressione ricercata.
Matt Mitchell (1975) ha pubblicato il suo esordio solista “Fiction” per la Pi Recordings (etichetta discografica che al momento si sta distinguendo per il tipo di proposte esposte nelle forme free jazz con particolare riguardo alle timbriche): Matt ha ricevuto lusinghe da gran parte della crema jazz di New York (tra cui spicca la partecipazione ai progetti di Dave Douglas e Tim Berne) che lo descrive come un esploratore di strutture improvvisative complesse sviscerate con incredibile facilità di movimento; “Fiction” in effetti mostra una forma compatta ed omogenea (dall’inizio alla fine) di improvvisazioni che si basano su un virtuosismo ricercato e voluto, basato soprattutto sulla frammentazione dei ritmi. Quello che in primis passa per il cervello è un frullato di certe evoluzioni spigolose di Monk condite a quei saliscendi di tempo che erano propri di pianisti come Andrew Hill, ma è indubbio che le cascate di note udite si possano rifare ai lampi accecanti di Cecil Taylor così come a quelli del McCoy Tyner di “Enlightenment”; ne deriva a livello evocativo una sorta di piano post-industriale che è veramente una novità per il jazz, che fa pensare anche a strutture modulari (sulla falsariga di quelle di Nik Bartsch, sebbene molto distanti per caratteristiche musicali). Mitchell in questo esordio è coadiuvato dall’indispensabile supporto del batterista Ches Smith (che in verità costituisce l’occasione per mettere in mostra anche le sue ottime qualità di batterista) con cui intavola continuamente un dialogo interattivo che intuitivamente richiama un’aggressione continua sugli strumenti portata avanti in continuo divenire. Sentire i dieci minuti circa di “Action Field” per credere.
Riprendendo quella suddivisione recentemente fatta dal pianista D’Andrea e riportata su youtube come parte di una lunga intervista sulle tendenze del piano, le due odierne correnti da lui citate (chiaramente non esaustive) di aderenza dei pianisti jazz a modelli di stile sembrano essere divise tra rimescolatori storici globali e discendenti dell’asse Debussy-Evans-Jarrett: Aaron Parks (1983) potrebbe rientrare nel secondo filone citato specie se si ascolta il suo primo vagito completamente in solo pubblicato per Ecm “Arborescence“; Parks si era già messo in luce nel 2008 con “Invisible Cinema” (il suo debutto da leader con un quartetto assieme ad Harland, Penman e Moreno) con un progetto validissimo al limite della fusion dove brani come “Harvesting dance” mostravano una trance non indifferente. “Arborescence” è parecchio diverso da Invisible Cinema ed in qualche modo mostra molto più coraggio: Parks non ama il virtuosismo, è un sensitivo di quelli che provengono dalla riscoperta di quel filone neoclassico che parte da Debussy e Satie e che è tanto di moda oggi; ma in “Arborescence” ne fuoriesce una caratterizzazione fortissima dell’autore, che mostra un respiro drammatico ben più potente di quello dei francesi del primo novecento: è un pianismo delicato a tratti (che ha anche qualche punto in comune non solo con Jarrett ma anche con pianisti di fusione come Lyle Mays) e forte e pieno di pathos drammaturgico in altri.