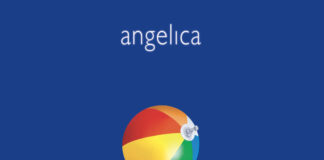Musicalmente regioni come il Mali in Africa hanno dettato quasi legge nell’àmbito dell’espansione commerciale della cultura africana. Questo fenomeno implicito suggellato dall’incontro a Timbuktu di Ry Cooder con Ali Farka Toure, ha estremizzato il forte senso del blues invischiato nella naturale versatilità della musica del Mali alla ritmicità; questo processo di evoluzione è stato coltivato in varie maniere: alcuni musicisti del posto hanno preferito riportare/riscoprire l’anima di strumenti tradizionali tra cui la kora è lo strumento che rimane più gradito nelle eccellenze del posto; altri hanno accentato la parte ritmica della musica (invero forse anche abusando di questo principio) cercando di preservare una tipologia di prodotto che potesse essere di gradimento ad un pubblico più ampio; il tutto si è affermato spesso con l’aggiunta di un carattere di protesta, espressione delle difficoltà incontrate dalla gente di quei luoghi negli ultimi anni e che ha costretto molti musicisti ad emigrare quasi perennemente in forme nomadi.
Quella densità ritmica è oggi croce e delizia delle nuove generazioni di artisti che si presentano (anche in forme patriarcali) sulla scena: da una parte c’è l’inevitabile rischio della ripetizione, dall’altra proposte ben congegnate dal lato musicale/antropologico non possono essere in alcun modo trascurate. Non è solo il centro abitato ad essere coinvolto ma anche la periferia, ossia tutte quelle zone ad est ed ovest del deserto del Sahara che sono quelle in cui più sentiti e minacciosi sono i problemi da risolvere dal punto di vista sociale e politico. La musica li riflette in qualche modo ed è un desiderio anomalo quello che raggiunge i musicisti di un popolo, musicisti che desiderano fuggire vedendo in tv città come Parigi, ma che allo stesso tempo si rendono conto di come sia importante che ci sia qualcuno che denunci le situazioni interne, talvolta vissute in prima persona.
Qualche bell’esempio discografico conferma quanto detto.
Combattuta dal desiderio di porre una propria carriera e preservare il suo interesse verso il Mali, Mamani Keita, ha dovuto affrontare la povertà e l’emigrazione prima di trovare un più solido habitat: dopo un paio di episodi discografici mischiati davvero male con il jazz e l’intrattenimento, la Keita registrò nel 2011 il suo più bel disco “Gagner l’argent francaise“, in cui spogliatasi di quel jazz deviante, lasciava scoperta coerentemente la voce etnica con tanto di ritmica in sovrapposizione; in questo suo ultimo “Kanou” l’artista, pur non raggiungendo gli stessi vertici espressivi del precedente, si ripete negli intenti, anche se con meno frenesia.
La figura femminile è un elemento importante nell’attuale protesta che viene dal Nord Africa: in particolare nel Sahara occidentale, una regione che sta vivendo problemi di eremitaggio politico non ancora risolti, le popolazioni sahrawi si stanno man mano evidenziando a livello musicale. Il box pubblicato nel 1998 dalla Nubenegra (un’etichetta spagnola dedicata), “Sahrauis: the music of the Western Sahara“, costituisce una prima fondamentale testimonianza della musica di quella zona, in cui poter ascoltare la forza della protesta di cantanti come Mariem Hassan e Aziza Brahim, o del chitarrista Nayim Alal. Esce in questi giorni il nuovo cd della Brahim, “Soutak“, una rappresentazione convincente che può porsi di fianco a lavori eccellenti come “Shouka” della Hassan.
Ma la Brahim non è certamente l’unica combattente: quello del sound desertico, portatore di musica ed orgoglio nazionalistico, arriva anche dalla parte nord-est del Sahara: figli della rappresentazione di gruppo, i Tinariwen, mai come nel loro recente “Emmaar“, sembrano avvicinarsi ad un sound tipico ed universale del Mali: ormai ritenuti realtà consolidata anche nell’occidente musicale dell’ascolto etnico, i Tinariwen è da tempo che stanno vivendo quella burrascosa situazione ad est del Mali che vede le incursioni di alcuni gruppi islamici non allineati e sembra che abbiano perso (a causa della guerra) anche alcuni elementi del gruppo.