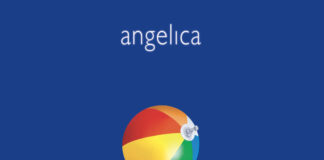Molti appassionati della musica rock si sono spesso interrogati su quale importanza attribuire alle due carriere consequenziali che Peter Gabriel ha avuto prima e dopo la rottura con i Genesis: se di questi falsi problemi ne è stata piena la stampa che fu, quello che invece va rimarcato è come l’impegno di Peter, sempre indirizzato nel fornire un prodotto musicale che fosse al tempo stesso “artistico” e “popolare”, non è mai scemato. Il suo grande sogno, quello di costruire una nuova identità delle coscienze politiche, tramite le relazioni e il dialogo con le forze in campo, è un’estrinsecazione del suo carattere, da sempre attento al mondo circostante e alle sue necessità. Con i Genesis dovette soccombere non appena il movimento punk spazzò tutti i residui granelli di presunta eresia del rock: l’eretico era un ambiente in cui Gabriel allora forniva l’iconicità e l’esempio di una filosofia contraria al ritorno della musica alle sue origini, quelle del rock’n’roll portatore di messaggio diretto, grezzo e sprezzante; Gabriel (non solo per dissidi interni, ma per aver carpito una modificazione nel linguaggio dell’audience del pop) gradualmente si avvicinò alla musica elettronica leggera; il cambiamento era dettato probabilmente dal fatto che egli si rendeva conto che i messaggi art-rock che provenivano da eminenti trasfigurazioni dell’immagine o dell’ardito riferimento alla mitologia letteraria, non si riscontravano nella nuova generazione di ascoltatori di musica; i driver di interesse non erano più dietro le velleità di un disco in vinile o di un libro sviscerati nelle mura della propria abitazione; si andava sviluppando un senso della “condivisione” da portare in piazza. Accogliendo questa considerazione, Gabriel man mano accolse la parte più ritmica e tribale dell’elettronica, le diede una maggior potenza, per segnalare come i problemi del singolo erano diventati i problemi comuni del mondo: “Biko”, la sua canzone dedicata all’attivista sudafricano contro l’apartheid è ancora oggi l’esempio per accedere al nuovo “segnale ritmico rivelatore”, che vuol denunciare diritti non rispettati, povertà incredibilmente mai risolte e schiavitù psicologiche determinate dalla politica.
“So”, poi, grazie ad una serie di brani e alla nascita di una produzione adeguata, diede un senso internazionale ai problemi dell’emigrazione: “Don’t give up” commuoverà per essere stata l’inno interiore delle generazioni di emigranti degli ottanta, ancora alle prese con grandi difficoltà di riconoscimento. Ma il suo capolavoro, Gabriel lo fece con la colonna sonora di “Passion: The last temptation of Christ” un film diretto da Martin Scorsese, in cui una figura di Dio di una umanità sconvolgente, faceva bella mostra dentro un oceano di suoni sintetizzati dalle matrici etniche, provenienti soprattutto dall’area mediorientale. “Passion: The last temptation of Christ” fu non solo la celebrazione della Real World (che è anche l’etichetta discografica fondata da Gabriel) e del sottaciuto mondo dei musicisti etnici, ma fu anche il crocevia di molti connubi impensabili tra generi diversi della musica che da quel momento cominciarono a camminare insieme e non più separati. “The last temptation of Christ” era un pozzo di idee: il drumming talk di Hassell che si incontrava con l’umore dei canti mediorientali, i campionamenti di strumenti esibiti in forme atipiche con piena presa di potere delle nuove tecnologie, i pioneristici connubi tra canzone pop occidentale e canzone popolare delle etnie, scampoli di minimalismo che si introducono in strutture di elettronica, e per il tema trattato, arte visiva cinematografica supportata da una vera colonna sonora, estraibile dal contesto senza essere tacciata di credibilità. Un album fondamentale non solo per la musica etnica e il suo divenire, ma per la musica in generale, perchè per la prima volta il tema della passione di Cristo venne trattato con le armi di una modernità scesa sino in basso, al suo livello più ampio di recettività.
Un drum beat che è una spia forte ed udibile, un faro illuminato ad intermittenza da cui è partito il grido di una generazione resa sfortunata da Dio, invischiata in guerre, malattie e problemi economici e che aveva il bisogno di avere una chance di riscatto. Per questo motivo, per il progetto di The Elders e per la sua bontà di uomo con il migliore degli scopi umani da raggiungere, gli possiamo tranquillamente perdonare anche quelle concessioni allo spettacolo (le esaltazioni concertistiche spesso tese solo a creare l’effetto scenografico) e le direttive alquanto confuse che la sua etichetta la Real World ha preso negli ultimi anni.