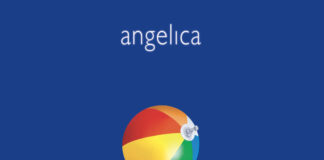Nel decennio degli anni settanta in America si impose una nuova ed importante figura nel panorama musicale: quello del cantautore “romantico”. Larghe schiere di musicisti con un forte background nella musica tipicamente americana (rock’n’roll, blues, country e in molti casi con chiare influenze dylaniane) si imposero all’attenzione di pubblico e critica, per le loro inebrianti melodie. Bob Seger, Bruce Springsteen, John Cougar Mellecamp e Tom Petty furono i massimi esponenti di questa nuova e sapida filosofia del rock che faceva da contraltare con l’emergente scena di Los Angeles di quegli anni, la quale stava partorendo artisti “seminali” come Tom Waits, Joni Mitchell, Jackson Browne.
Seger cominciò a pubblicare musica nel 1968, quando il romanticismo nel rock stava facendo i suoi primi passi per guadagnarsi un matrimonio con l’attività sociale, un trade d’union su cui Bob Dylan stava lavorando magnificamente in chiave filosofica. Seger aveva senza dubbio meno filosofia rispetto a Dylan, ma rispetto a quest’ultimo anche un vantaggio, quello di lavorare con efficacia sulla mistura degli elementi americani della musica: sotto questo punto di vista, Seger può considerarsi come un vero e proprio anticipo di quello che diventerà la musica americana dopo la metà dei settanta. Ma non è tutto. Il rock’n’roll, dopo l’effervescente periodo iniziale della sua vita in cui aveva partorito la prima vera rivoluzione musicale della musica leggera grazie ai contributi di Chuck Berry, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, etc., nei sessanta aveva subito un’evoluzione che gli aveva fatto perdere la memoria storica sul punto: fu proprio Seger, che scrisse dei nuovi, moderni episodi che non fossero mera clonazione di quello che era stato fatto dall’universo musicale del passato.
In possesso di una voce straordinaria, timbricamente plagiata dall’ascolto intenso della musica nera, frutto delle lunghe giornate passate ad ascoltare alla radio Wilson Pickett e James Brown, Seger non perse tempo a proporsi alla comunità musicale non appena capì di poter contare proprio su quella voce: il primo periodo discografico non fu semplice, poichè Seger non aveva ancora maturato il suo stile e si accontentava di rifare lo stile altrui, tuttavia alcuni brani tratti dall’esordio Ramblin’ gamblin’ man (hard blues allo stato puro) o dagli albums successivi (il soul derivato di Mongrel, il rock poliglotta di Smokin’ O.P.’s), lo ponevano già in considerazione come personaggio assolutamente non scontato. Il suo primo lavoro di caratura sarà Brand New Morning, in cui si stabiliscono le sue vere coordinate: l’album, in perfetta solitudine strumentale (voce, piano e chitarra), è una di quelle perle nascoste della sua discografia che mostra l’essenzialità dell’artista, che finalmente matura anche un personale stile di approccio alla composizione.
Back in ’72 è la conferma (con una veste pienamente musicale) di quello che Seger stava facendo in quegli anni: il sound è vario e riprende i generi principe americani (blues, rock’n’roll, soul) con una forte componente emotiva soprattutto nella ballata che, grazie al canto roco inimitabile dell’artista di Detroit, non ha nulla da invidiare ai migliori cantanti del soul americano, anzi ne amplifica i confini.
In Seven, poi, compare anche una personale vena di ironia sociale nel blues di UMC (Upper Middle Class), che accompagna i nuovi classici dell’artista; quello che stona un pò è l’inserimento di qualche cover di troppo, ma per il resto nel rock non c’era niente di più eccitante di Seger e i suoi concerti dal vivo lo testimoniavano. Con la nascita della Silver Bullet Band, Seger fa un ulteriore passo distintivo nella qualità della sua musica: la band diventerà una leggenda degli spettacoli dal vivo di rock, contribuendo al Live Bullet, un live che ben coglieva le perfomances di Seger e band, con un evidente arrichimento propulsivo introdotto nella composizione; la quaterna di dischi Beautiful loser/Night Moves/Stranger in town/Against the wind gli porta un successo strameritato, nonchè l’apprezzamento quasi unanime della critica mondiale del rock. Scrive una sequela di canzoni memorabili, semplici dal punto di vista strutturale, ma con un feeling emotivo da far spavento. Melodico al punto giusto da non sconfinare in nessuna banalità, spesso con esplosioni di energia al limite della durezza sonora, si pone come un osservatore della realtà della vita che non vuole effettuare nessun approfondimento, si limita solo a far emergere quello status (sia di difficoltà che di gioia) attraverso il potere di esternazione della sua musica; sono solo quelle le vibrazioni che contano alla fine. E’ la scoppiettante America di quegli anni che si sta raccontando, con una parte di essa che viveva ancora con speranza e positività le sue frustrazioni.
e per una sua valutazione dal vivo, naturalmente Live Bullet, Capitol 1976.
1) il blues, noto genere afroamericano nato agli inizi del novecento in America come canto di sofferenza e poi pian piano evolutosi tramite un graduale processo di elettrificazione del sound (tali da creare le varianti del R&B e del soul),
2) il rock’n’roll, genere popolare derivante dal boogie-woogie, variante pianistica ritmica del blues di inizio secolo,
3) il country, cioè la musica delle campagne americane,
4) il folk, che si emancipò dal country grazie all’inserimento della protesta sociale di Woody Guthrie, quando poi acquisirà uno status filosofico grazie a Dylan che la farà diventare musica d’autore.
Sono i generi che hanno salvato la vita a tanti americani: sono i generi abbracciati da un giovane musicista “romantico” di Asbury Park: Bruce Springsteen. Quest’uomo ha avuto un’importanza vitale per la musica popolare, riuscendo a coniugare in un proprio straordinario stile le istanze delle classi sociali più deboli, fornendogli il coraggio di andare avanti, sopravvivere alle difficoltà e addirittura redimersi dai bassifondi raggiunti.
Inizialmente considerato come un clone di Dylan da certa critica distratta, Springsteen entra in gioco nel periodo in cui il menestrello di Duluth sta attraversando un periodo di transizione verso forme più popolari, ma in realtà Springsteen era qualcosa di diverso: non possedeva il talking blues dylaniano ma spiccati erano i riferimenti alla musica nera e alla ballata soul; il suo folk non aveva la stessa intensità poetica di Dylan, non volava leggero e profondo, ma si caratterizzava per un tono epico; grazie anche alla sua band, la rotolante E-Street Band, in lui riviveva a caratteri cubitali lo spirito rock’n’roll dei concerti di Chuck Berry. Il suo concetto di riscatto Springsteen se lo è portato dietro sin dagli esordi di Greetings from Asbury Park, album assolutamente da rivalutare, che lo propone già cantautore di alto livello, ma poi si continua con una serie di albums che tutto ad un tratto diventano attessissimi sia da pubblico che critica e lo consacreranno negli anni ottanta come il più eccitante cantante che il rock avesse mai avuto.
Come scrive Massimo Cotto nel libro a lui dedicato dell’Arcana….”….ha sistemato la sua ordinary people in uno scenario di cento strade diverse su ognuna delle quali si combatteva una battaglia: la (Thunder) road della Redenzione, la freeway della Fuga, la backstreet in cui nascondersi, la street dove gareggiare per non rimanere intrappolati dalla vita, la highway della libertà ma anche degli incidenti, gli alleys in cui si muove il popolo delle jungle lands, i boardwalk dell’infanzia, la promenade dei coraggiosi, il boulevard dei Dean di periferia…..” Musicalmente Springsteen si presenta, dopo il più delicato esordio, con una esplosività di temperamento, concerti in cui non bada a sprechi fisici, ma è soprattutto una vera polveriera di comunicazione umana: ognuno, almeno fino all’album Born in the Usa, può scegliere il suo preferito. Poi da Tunnel of love, disco pubblicato in occasione del suo matrimonio, il suono subisce un cambiamento, è spesso senza band, cerca di essere intimista, ma non riesce più a colpire a fondo come in quel decennio di meraviglie che è stato il 1973-1983. Un sussulto si ha nel 1995 con l’album The ghost of Tom Joad, una meraviglia folk con il brano omonimo che suonato ad inizio festival di Sanremo manda in visibilio il problematico pubblico dell’Ariston. La verità è che l’artista riscuote un successo interplanetario e forse, leggermente schiavo delle major discografiche, centellina l’attività discografica, la quale si riduce sensibilmente per contare più sulla promozione “live”: è necessario l’attentato alle Torri Gemelle per rivederlo con un nuovo disco apertamente dedicato alle vittime di quella tragedia: ma nonostante qualche valido episodio, il disco dà forti dubbi sulla validità degli arrangiamenti trovati. Molto positiva la riproposizione dei brani di Pete Seeger, una delle sue influenze, fatta in chiave jazz-band, ma la sua produzione solistica, anche quando si riunisce con la E-Street band, è dispersiva e lontanissima dalla quella grezza, forte e romantica presenza degli anni settanta, da quell’enfasi che ha modellato sostanzialmente tutte le generazioni di rockers dei decenni successivi.
Discografia consigliata:
-Greetings from Asbury Park, Cbs/Columbia 1973
-The Wild, the Innocent & the E-Street Shuffle, Columbia, 1973
-Born to run, Columbia 1975
-Darkness on the edge of town, Columbia 1978
-The River, Columbia 1980
-Nebraska, Columbia 1982
-Born in the Usa, Columbia 1984
-The ghost of Tom Joad, Columbia 1995
Tom Petty fu inizialmente scambiato per un punk (in quegli anni imperversava la moda di un genere che ormai non era più un fenomeno solo inglese), ma il suo stile si riconosceva subito, un misto di folk-rock alla Byrds, di Dylan e sprazzi di rock’n’roll e blues; su tutto svettava la sua particolare timbrica di voce adolescenziale da rocker. Petty si mise a capo degli Heartbreakers, un gruppo formato da molti valenti amici musicisti (Mike Campbell e Benmont Tench tra essi) e nel 1976 esordì con l’album omonimo, con cui stabilirà il suo status discografico, qualcosa che lo vedrà con cadenza quasi regolare pubblicare dischi con le stesse caratteristiche musicali. I primi due lavori di Petty (Tom Petty & The Heartbreakers e You’re gonna get it), pur non essendo pienamente maturi sul versante musicale, mostrano già un’ironia testuale sui tipici comportamenti che costituiscono l’universo giovanile dell’America di quegli anni (le relazioni, la cattiva televisione, la necessità di una buona finanza). Al terzo album Petty sfodera però quello che sarà considerato il suo capolavoro musicale: Damn the torpedoes presenta la sua band al massimo della forza, ha degli arrangiamenti molto più convincenti e ci consegna anche un cantautore più attento all’espressività delle forme e dei testi. Damn the torpedoes sarà annoverato tra i grandi dischi rock di tutti i tempi, nella sezione cantautori americani, in virtù di una serie di canzoni realmente ispirate: in particolare il trittico iniziale (Refugee, Here comes my girl, Even the losers) è una delle migliori successioni di canzoni rock formato “USA” su albums, qualcosa che funzionerebbe a meraviglia per qualsiasi passaggio radiofonico. Tom sfrutterà questo periodo di fertilità creativa siglando ancora tre lavori al livello di Damn the torpedoes: prima un bel disco con Hard promises, dove canzoni come The Waiting o Insider (con la cantante dei Fleetwood Mac Stevie Nicks al controcanto), mantengono alta l’attenzione sul musicista; poi, grazie alla produzione di Dave Stewart degli Eurythmics, Petty riuscirà a caratterizzare Southern Accents che, a dispetto di molta critica negativa, resta uno dei suoi migliori lavori di sempre; ed infine, con una più forte influenza dylaniana Petty si fa sentire politicamente in Let me up (I’ve had enough), che conferma il suo periodo di grazia con una side A di notevole impatto.
Nel corso del tempo il cantautore americano ha avvertito il bisogno di portare avanti anche progetti individuali ed alternativi: ha suonato con i Traveling Wilburys (il suo penultimo album è stato inciso con la band dei Mudcrutch) in un revival sixties e seventies poco interessante, e parallelamente c’è stata la sua carriera solistica: il suo esordio da solista Full moon fever non è altro che una via di mezzo tra lo stile degli Heartbreakers e quello dei Traveling (che partecipano al completo) e quindi, anche dal punto di vista qualitativo, si divide equamente in una A-side rilevante e una B-side poco accattivante. Più omogeneo il suo secondo sforzo solista Wildflowers, che pur aderendo in molti momenti ad una fedele riproposizione della musica dei Byrds, contiene alcuni dei suoi migliori brani in assoluto, dalla title-track a Time to move on o Wake up time. Poi nel 1999 ancora un buon album con gli Heartbreakers intitolato Echo e poi, purtroppo un decennio decisamente sottotono, anche nella versione solista.
Petty è un’artista di una moralità dirompente, sempre fedele e corretto nel proporre una musica di cui conosce benissimo i limiti. Con la sua band Petty ha fornito una versione pulita e decisamente meno sguaiata dei Rolling Stones ed ha contrastato con ferocia il mondo del business musicale, teso come sempre alla massimizzazione dei profitti.
Big Daddy del 1989, Human Wheels e Dance Naked rappresentano una ulteriore continuazione del discorso intrapreso con The Lonesome jubilee, il primo ha meno invadenza musicale, gli altri stringono l’occhio anche al R&B e alla musica nera, con John che continua a migliorare anche dal punto di vista vocale. Ad un certo punto la qualità della carriera di Mellecamp comincia ad andare a corrente alternata: da una parte l’artista ripropone la sua personale miscela di rock in validi album come Mr. Happy go lucky, parzialmente Cuttin’ Heads, dall’altra vira decisamente indietro nel tempo facendosi ennesimo portavoce del folk delle origini (vedi Trouble no more) che costituiscono in definitiva un’involuzione musicale. Life, death, love and freedom del 2008 sorprendentemente costituì la sua rinascita artistica: Mellecamp aveva realmente ancora qualcosa da dire sebbene lo facesse con una strumentazione nettamente più elettrica, in questo favorito dalla produzione di T-Bone Burnette.
In Plain spoken del 2014, Cougar compie un riassetto dei suoi poemi acri, che sanno di dubbi ed amarezza: i temi sociali hanno subito un ridimensionamento rispetto al passato, ma la prospettiva delle idee nella loro risoluzione non è minimamente cambiata: quando in “The real life” (contenuto in The lonesome jubilee) il 62-enne musicista dell’Indiana si poneva dubbi sulla validità del modello di vita familiare americano, era consapevole che la vita è simile ad una drammaturgia, di quelle vicine alle architetture di Tennesse Williams o John Steinbeck, due autori generalmente seguiti dai cantautori americani legati alle correnti popolari. Niente è certo. Ma oggi c’è una variante: l’uomo agreste è in ulteriore difficoltà causa il brodo religioso che da convinzioni cristiane sta assumendo altri contorni. “Plain spoken” riflette tutto questo, veicolato tramite un consolidato american musical style, fatto di voce e chitarra ma senza dimenticare di inserire le spezie preziose (violini, mandolini, contrabbasso), e che lo avvicina al suo periodo migliore, quello degli intorni di The lonesome jubilee. Il gran trittico iniziale (Troubled Man/Sometimes There’s God/The isolation of master) soprattutto lo riabilita a tuttotondo nella vocazione di scrittore di canzoni.
Discografia consigliata:
-American Fool, Riva 1982
-Scarecrow, Riva 1985
-The lonesome jubilee, Mercury 1987
-Big daddy, Mercury 1989
-Human wheels, Mercury 1993
-Mr. Happy go lucky, Mercury 1996
-Life, death, love and freedom, Hear Music 2008
-Plain Spoken, 2014