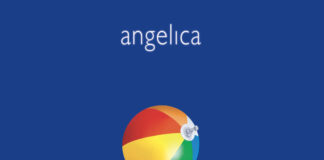E’ emblematico di come funzioni oggi il jazz internazionale: le nuove generazioni di musicisti, da oltre un ventennio, hanno cercato di mettere assieme tutte le scoperte della musica anche se provenienti da settori non affini al jazz. In particolare, il jazz che si è imposto in questi decenni, è succube di una matrice “mainstream” in cui ognuno cerca di trattare i parametri che la compongono; è una formula che è maledettamente criticata, poiché mancherebbe di autenticità e costringerebbe ad una visione unitaria, priva dell’anima che alimentava il jazz di un tempo. Ma è anche l’unica forma possibile quando si tratta di restare nei canoni della normalità (in termini di armonia, melodia e ritmo): in questa sfera applicativa sono molti i musicisti commercialmente importanti che ne fanno parte e che dipingono l’attività discografica delle principali labels americane e inglesi. E’ una cordata variabile che coinvolge musicisti come Metheny, Mehldau, Binney, Moran, Potter, Gilmore, Harrison e tanti altri. Per molta loro produzione spesso si fa fatica a riconoscere diversità, poiché anche qui si è creato un canovaccio riconoscibile degli elementi profusi: un’attacco dinamico che “tiene desto” l’ascoltatore, un tema (molto spesso corale) che deve imporsi per le sue qualità vitali (ma spesso astruse), degli assoli rassicuranti che devono tener distante follie e pene: chi conosce questi artisti sa di cosa parlo e sa anche come si possa fare buona musica lavorando attentamente sui materiali e sull’espressività. Quello che vorrei sottolineare non è la disaffezione dei musicisti ad una tipologia di suoni diversa, ma piuttosto la loro inconscia voglia di soddisfare comunque le esigenze del pubblico. Prendo un recente caso campione: a proposito del bravissimo pianista John Escreet, inglese di nascita ma americano d’adozione musicale, Dan Bilawsky in una sua recensione scritta per l’artista in occasione di “The age we live in” giustamente sottolineava come il mix di jazz, scansioni rock, elettronica spezzettata ed altro, fosse l’estrinsecazione di un modo di sentire la società attuale ….”The ages we live in … takes the racing pace of the modern day man and refracts it through a musical prism, creating heart-pounding sounds that thrillingly reflect how we move through life….”. Escreet, la cui maturazione si è completata in Don’t fight the inevitable nel 2010, mi sembra un ottimo portavoce di questa volontà a cavallo in cui da una parte si tenta di risolvere questa equazione post-moderna in cui si trova il jazz odierno e dall’altra, nelle attività jazzistiche parallele a quelle ritenute di facciata, si fornisce esempio di progetti jazzistici extra che percorrono anche altre direzioni, le quali sono diverse dal soddisfacimento semplicistico di un pubblico jazz che fa fatica a perdere la rotta dei venti del passato. Al riguardo, Escreet dal 2010 ha parallelamente mantenuto un suo trio, nettamente più sperimentale ed improntato all’appagamento timbrico ed acustico, con il contrabbassista John Hébert e il batterista Tyshawn Sorey, in cui ha digerito altri “sogni” (vedi qui una loro perfomance): nel settembre del 2013 il trio ebbe l’occasione di incontrarsi con Evan Parker, che era a New York per curare un programma al The Stone e ne venne fuori un’esibizione che è stata immortalata in “Sound, space, structure” per la Sunnyside R.: immerso in un clima completamente rivolto alla libera improvvisazione e alle libere tecniche, il concerto dimostra l’invidiabile forma di Parker, che grazie alla respirazione circolare, ha creato un suo idioma riconoscibile (l’arpeggio prolungato al sax debitamente enfatizzato), ma allo stesso tempo suscita domande su quale proiezione possa avere la musica di Escreet e del suo trio nella dimensione sperimentale, free, in cui lo scopo è creare oasi strumentali; l’ascolto rivela, soprattutto per Escreet, un controllo delle variabili, forse mai completamente abbandonato alla casualità, che dimostra però di possedere una particolare idea di approccio subdolo al piano, che si evidenzia nei momenti in cui si gioca sulle note alte e su rivoli di registri alti indotti da arpeggi.
“Sound, space, structure” metterà allora in allarme coloro che si sono sempre lagnati della mancanza di coerenza dei musicisti di oggi e soprattutto richiama un’altra considerazione che è legata strettamente al valore dell’improvvisazione: per essere un buon improvvisatore è necessaria un’attitudine coltivata, un’abitudine ad essere praticata a certi livelli? E’ meglio, come pensano in molti, restare coerenti, metter su delle intere discografie “fantasma” e restare famelicamente agganciati al margine di opportunità musicali della realtà odierna, una realtà che spinge al compromesso per l’esistenza e nella quale essi non si riconoscono?