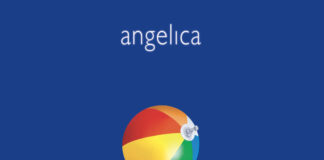L’interesse verso il mondo percussivo indonesiano ed in particolare la saga del gamelan, spinse molti europei a farne una conoscenza diretta: alla fine degli anni settanta, negli Stati Uniti, qualcuno intravide una funzione meditativa e spirituale che poteva ben formare un’integrazione con le teorie sperimentali di Cage, tese alla mediazione tra i suoni tout court e il silenzio. Quell’apparente contrasto portò alla nascita di un gruppo di compositori residenti a New York che si specializzarono nella composizione di questo tipo: Philip Corner, Barbara Benary e Daniel Goode furono alcuni tra quelli che diedero vita a speciali e stranianti organizzazioni musicali in forma anche di collettivo, dedicati specificatamente allo scopo (il Gamelan Son of Lion), dove in essi gli stessi rivestivano la doppia qualità di compositore ed esecutore. In particolare Corner si rivelò come il più attivo e ingegnoso e fece proprio del gamelan uno dei suoi primi cavalli di battaglia: i suoi 2 works for Gamelan Ensemble, originariamente incise per la serie militante della Edizione Lotta Poetica e poi ristampati con l’aggiunta di una terza composizione per l’Algha Marghen nel 1999, ancora oggi si possono ritenere come un riuscito lavoro di compenetrazione tra composizione contemporanea, improvvisazione e sperimentazione sonora, sebbene frutto indotto del Fluxus e dell’epoca dei rapporti tra il silenzio e i suoni, imposti da Cage. Quello era un periodo in cui fioccava l’interesse per le ibride operazioni e per l’affermazione di un necessario senso di accettazione delle avanguardie artistiche e a New York, Corner ne diventò un importante delegato. Nel 1991, Corner ebbe modo di incontrare uno dei più strani rappresentanti del gamelan indonesiano: si trattava di Rahayu Supanggah, che venne invitato nel loft dell’americano per una sessione nata nell’ambito della celebrazione dello Year of Indonesia. Supanggah suonò tamburi, varie percussioni e flauto di bambù, mentre Corner si impegnò in piatti, gongs e altre percussioni similari. Questa sessione che la Setola ha ottenuto e riordinato come “Together in New York” mostra proprio un trait de union tra le mentalità dei due artisti ed un taglio sperimentale che è lontanissimo dall’evocare pastoie etniche riciclate; non so quante pubblicazioni abbia fatto Supanggah in madre patria, ma certamente quelle destinate ad un pubblico internazionale si possono contare sulla punta delle dita, perciò è certamente una documentazione preziosa quella offerta dalla Setola e indica, nonostante la evidente datazione delle perfomances (parliamo del 1991), la propensione dei due a convergere verso una forma diretta, artigianale, totalmente impostata alla scoperta di nuovi suoni casualmente forniti dai gesti sonori: due lunghe improvvisazioni dal volto diverso, la prima quasi kitchen sound, la seconda che invece sprofonda nella ricerca dell’enigmaticità dei suoni; si scorazza nei territori dell’improvvisazione libera, trovando comunque un compromesso tra radici ideologiche, espressività da libero arbitrio e l’imperscrutabile fascino dei sogni orientali.
L’interesse verso il mondo percussivo indonesiano ed in particolare la saga del gamelan, spinse molti europei a farne una conoscenza diretta: alla fine degli anni settanta, negli Stati Uniti, qualcuno intravide una funzione meditativa e spirituale che poteva ben formare un’integrazione con le teorie sperimentali di Cage, tese alla mediazione tra i suoni tout court e il silenzio. Quell’apparente contrasto portò alla nascita di un gruppo di compositori residenti a New York che si specializzarono nella composizione di questo tipo: Philip Corner, Barbara Benary e Daniel Goode furono alcuni tra quelli che diedero vita a speciali e stranianti organizzazioni musicali in forma anche di collettivo, dedicati specificatamente allo scopo (il Gamelan Son of Lion), dove in essi gli stessi rivestivano la doppia qualità di compositore ed esecutore. In particolare Corner si rivelò come il più attivo e ingegnoso e fece proprio del gamelan uno dei suoi primi cavalli di battaglia: i suoi 2 works for Gamelan Ensemble, originariamente incise per la serie militante della Edizione Lotta Poetica e poi ristampati con l’aggiunta di una terza composizione per l’Algha Marghen nel 1999, ancora oggi si possono ritenere come un riuscito lavoro di compenetrazione tra composizione contemporanea, improvvisazione e sperimentazione sonora, sebbene frutto indotto del Fluxus e dell’epoca dei rapporti tra il silenzio e i suoni, imposti da Cage. Quello era un periodo in cui fioccava l’interesse per le ibride operazioni e per l’affermazione di un necessario senso di accettazione delle avanguardie artistiche e a New York, Corner ne diventò un importante delegato. Nel 1991, Corner ebbe modo di incontrare uno dei più strani rappresentanti del gamelan indonesiano: si trattava di Rahayu Supanggah, che venne invitato nel loft dell’americano per una sessione nata nell’ambito della celebrazione dello Year of Indonesia. Supanggah suonò tamburi, varie percussioni e flauto di bambù, mentre Corner si impegnò in piatti, gongs e altre percussioni similari. Questa sessione che la Setola ha ottenuto e riordinato come “Together in New York” mostra proprio un trait de union tra le mentalità dei due artisti ed un taglio sperimentale che è lontanissimo dall’evocare pastoie etniche riciclate; non so quante pubblicazioni abbia fatto Supanggah in madre patria, ma certamente quelle destinate ad un pubblico internazionale si possono contare sulla punta delle dita, perciò è certamente una documentazione preziosa quella offerta dalla Setola e indica, nonostante la evidente datazione delle perfomances (parliamo del 1991), la propensione dei due a convergere verso una forma diretta, artigianale, totalmente impostata alla scoperta di nuovi suoni casualmente forniti dai gesti sonori: due lunghe improvvisazioni dal volto diverso, la prima quasi kitchen sound, la seconda che invece sprofonda nella ricerca dell’enigmaticità dei suoni; si scorazza nei territori dell’improvvisazione libera, trovando comunque un compromesso tra radici ideologiche, espressività da libero arbitrio e l’imperscrutabile fascino dei sogni orientali. Un’installazione piuttosto suggestiva che coinvolge l’abbinamento tra suoni e dipinti è la “peinture sonore”: si tratta di un’interazione diretta tra il musicista (o i musicisti) e il pittore particolarmente gradita agli improvvisatori e ritrattisti, poiché spesso assume le sembianze di una silenziosa attività di ricerca in cui si cerca di improntare un sistema per decodificare segnali acustici che dall’orecchio passano alla mano ritrattista: attraverso l’introspezione e l’improvvisazione profusa nel corso di una perfomance, in cui tutto l’ambiente circostante reclama un suo valore, il musicista regala al pittore le coordinate su cui muoversi: è una sorta di improvvisazione a due livelli, uditiva e pittorica, in cui la musica dà suggerimenti all’immaginazione dei dipinti. Applicata soprattutto in Francia, la peinture sonore regolarmente scava nella platea dei consigli indefiniti proposti da Cage, in cui l’attività improvvisativa del musicista richiede un suo metalinguaggio, un proprio approccio creativo che non può temere di peccare di poca originalità: in “Cielo 2“, solo piano della pianista giapponese Yoko Miura, si condensa gran parte di quella fase critica in cui il musicista si incammina inconsciamente su un sentiero di suoni, che non ha forme prestabilite o stili da seguire, che lascia inevitabilmente liberi sul cammino da farsi, giocando su dinamiche del momento, che possono attecchire casualmente i sentieri della risonanza o della semplice ebbrezza provata per una serie di note legate tra loro in accordo; in “Cielo 2” sarebbe un errore tentare di trovare dei riferimenti stilistici, perché realmente non se ne trovano: i drivers di questa prova solistica (individuabili soprattutto nelle più lunghe durate improvvisative, l’iniziale Epilogue/Spring/Spring haze e Improvisation) risiedono esclusivamente nella capacità di filtrare all’istante sulla tastiera gli impulsi interattivi celebrali. Pur non essendo finalizzato ad una peinture sonore, “Cielo 2” ne cattura le impostazioni introspettive, ponendo l’accento sulla qualità descrittiva della musica: combinazioni di note fatate ed un consistente uso dei pedali sulle tonalità basse atto a provocare un complessivo rimbombo armonico di fondo, sono gli elementi utili per fare emergere il significato e la straordinaria importanza/presenza della vita, rivelando tutta la sensibilità della pianista nei confronti della realtà.
Un’installazione piuttosto suggestiva che coinvolge l’abbinamento tra suoni e dipinti è la “peinture sonore”: si tratta di un’interazione diretta tra il musicista (o i musicisti) e il pittore particolarmente gradita agli improvvisatori e ritrattisti, poiché spesso assume le sembianze di una silenziosa attività di ricerca in cui si cerca di improntare un sistema per decodificare segnali acustici che dall’orecchio passano alla mano ritrattista: attraverso l’introspezione e l’improvvisazione profusa nel corso di una perfomance, in cui tutto l’ambiente circostante reclama un suo valore, il musicista regala al pittore le coordinate su cui muoversi: è una sorta di improvvisazione a due livelli, uditiva e pittorica, in cui la musica dà suggerimenti all’immaginazione dei dipinti. Applicata soprattutto in Francia, la peinture sonore regolarmente scava nella platea dei consigli indefiniti proposti da Cage, in cui l’attività improvvisativa del musicista richiede un suo metalinguaggio, un proprio approccio creativo che non può temere di peccare di poca originalità: in “Cielo 2“, solo piano della pianista giapponese Yoko Miura, si condensa gran parte di quella fase critica in cui il musicista si incammina inconsciamente su un sentiero di suoni, che non ha forme prestabilite o stili da seguire, che lascia inevitabilmente liberi sul cammino da farsi, giocando su dinamiche del momento, che possono attecchire casualmente i sentieri della risonanza o della semplice ebbrezza provata per una serie di note legate tra loro in accordo; in “Cielo 2” sarebbe un errore tentare di trovare dei riferimenti stilistici, perché realmente non se ne trovano: i drivers di questa prova solistica (individuabili soprattutto nelle più lunghe durate improvvisative, l’iniziale Epilogue/Spring/Spring haze e Improvisation) risiedono esclusivamente nella capacità di filtrare all’istante sulla tastiera gli impulsi interattivi celebrali. Pur non essendo finalizzato ad una peinture sonore, “Cielo 2” ne cattura le impostazioni introspettive, ponendo l’accento sulla qualità descrittiva della musica: combinazioni di note fatate ed un consistente uso dei pedali sulle tonalità basse atto a provocare un complessivo rimbombo armonico di fondo, sono gli elementi utili per fare emergere il significato e la straordinaria importanza/presenza della vita, rivelando tutta la sensibilità della pianista nei confronti della realtà.