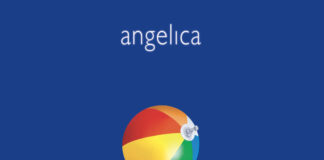Un ambientazione ultraterrena pare già rivelarsi nelle immagini di copertina di “Grand Valis“: l’ultimo lavoro del contrabbassista portoghese, Hugo Carvalhais, non dà adito a dubbi su dove si vuole arrivare; non c’è solo una ricerca musicale, compiuta con dei musicisti che si rapportano a lui con una ben precisa sintassi stilistica, ma anche un’esplorazione filosofica che surroga le affascinanti scoperte metafisiche del novellista Philip K. Dick. Il rimando ad uno dei suoi più apprezzati lavori è indirettamente fonte di conoscenza del pensiero di Platone e di tanto gnosticismo; l’aspettativa porrebbe l’ascoltatore di fronte all’evidente bisogno di una rappresentazione musicale che rispetti lo spirito di tanto martoriato approccio spirituale o che in qualche modo conservi contenuti da cui trarre in maniera soggettiva un’esperienza decisiva per la comprensione. In “Grand Valis” la fiction si compie sistemando le note in quel personale confine artistico che sta il jazz (sempre meno, quasi niente di quello tradizionale) e la classica contemporanea (sempre più, molto più di una semplice improvvisazione libera in circuito): mai come in questo caso i titoli dei brani sono indicativi di un processo di valutazione della musica e dei suoi significati. E’ impensabile che il contrabbasso di Hugo possa fare a meno dell’organo senza senno di Gabriel Pinto così come non può fare a meno degli inserti violinistici di Dominique Pifarély: far leva sull’atonalità e l’improvvisazione, dichiaratamente concentrata a creare immagini di un certo tipo, si dimostra ancora scelta vincente e l’intervento aggiuntivo richiesto ad uno degli improvvisatori più dotati delle manipolazioni elettroniche, Jeremiah Cymerman, volgarizza i termini storici dell’immaginazione e riporta il suono sulla condizione umana odierna. Quello che in passato ho chiamato contemporary jazz ha ormai in Carvalhais un paladino essenziale; egli distribuisce diversità di vario tipo ma che restituiscono un’inaspettata armonia sedicente: il contrabbassista viaggia su sincopi ad una corda che sembrano fuori luogo o sostiene la struttura musicale con libere escursioni, ma non è solo nel compito di creare una meravigliosa intelaiatura spettrale; Pifarély mostra idiomi cangianti del suo violino, che una volta è angelico, un’altra è teso verso l’atonalità, rimane spesso straziato, frammentato o irretito, quando poi in Holographic Maya è quasi in prostazione religiosa. Pinto puntella le ambientazioni con un organo che sta tra un carillon e uno a canne da chiesa, emulando una linea di sentiero che va dall’impostazione francese ottocentesca fino ai giorni nostri; Cymerman entra in questo patchwork con assoluta discrezione, la sua è un’operazione di cesellamento dei suoni che accresce le forme e il carattere enigmatico: in Digitalis si compie la spinta maggiore, quell’avvicinamento alla realtà tecnologica odierna, con una scarica finale dei suoni, la loro rivolta prima del finale di Zebra, emblematico di un imminente trapasso, dove il suono al lumicino dei musicisti, restituisce lo stadio ultimo di una conoscenza spirituale debitamente preparata.
 Il periplo scolpisce già nell’antichità greca l’idea del viaggio e della misura di una rotta di navigazione: con una registrazione disposta su bandcamp ci ha pensato il trio Colla Parte (Barbiero-Conticchio-O’Meara) a rimembrare l’importanza di queste mappe della circumnavigazione, diventate un genere letterario nell’esperienza greca; aggiungendo musicalmente un ulteriore elemento nelle percussioni del figlio di Rich O’Meara, Kevin O’Meara, questa terza prova dei Colla Parte non si preoccupa di creare contrasti mentali poiché punta sull’omogeneità del tema, sebbene i musicisti si muovono sempre con le stesse armi, lo stesso senso compiuto e lo stesso consueto affiatamento: quello che più volte ho ripetuto su questa sottovalutata formazione è il fascino della loro musica, che si presenta con un sapore art gallery fortissimo, trovato grazie ad un equilibrio fra free jazz di alta fattura e gestualità contemporanee; l’inserimento del batterista Kevin O’Meara porta in Periplus un ulteriore arricchimento di scopo, in una espressione composita che paga tributo all’improvvisazione senza disdegnare istinti classici. Il valore della suite di Periplus (sei movimenti che riprendono la rosa dei venti e dei posizionamenti marini) sta nella creazione di valore aggregato: Barbiero mostra un contrabbasso a stantuffo continuo; Conticchio (vero dominatore del brano) offre uno straordinario potere incantatorio che proviene da assoli versatili, ponti tra delicate sofferenze al sax e potenti escalation di forza free; Rich O’Meara dona poi al vibrafono quel senso di misterioso incedere che serve alla realizzazione dell’immagine subliminale; gli interventi di Kevin mostrano già una maturità ed una promiscuità tra stile libero e interventi in controtempo.
Il periplo scolpisce già nell’antichità greca l’idea del viaggio e della misura di una rotta di navigazione: con una registrazione disposta su bandcamp ci ha pensato il trio Colla Parte (Barbiero-Conticchio-O’Meara) a rimembrare l’importanza di queste mappe della circumnavigazione, diventate un genere letterario nell’esperienza greca; aggiungendo musicalmente un ulteriore elemento nelle percussioni del figlio di Rich O’Meara, Kevin O’Meara, questa terza prova dei Colla Parte non si preoccupa di creare contrasti mentali poiché punta sull’omogeneità del tema, sebbene i musicisti si muovono sempre con le stesse armi, lo stesso senso compiuto e lo stesso consueto affiatamento: quello che più volte ho ripetuto su questa sottovalutata formazione è il fascino della loro musica, che si presenta con un sapore art gallery fortissimo, trovato grazie ad un equilibrio fra free jazz di alta fattura e gestualità contemporanee; l’inserimento del batterista Kevin O’Meara porta in Periplus un ulteriore arricchimento di scopo, in una espressione composita che paga tributo all’improvvisazione senza disdegnare istinti classici. Il valore della suite di Periplus (sei movimenti che riprendono la rosa dei venti e dei posizionamenti marini) sta nella creazione di valore aggregato: Barbiero mostra un contrabbasso a stantuffo continuo; Conticchio (vero dominatore del brano) offre uno straordinario potere incantatorio che proviene da assoli versatili, ponti tra delicate sofferenze al sax e potenti escalation di forza free; Rich O’Meara dona poi al vibrafono quel senso di misterioso incedere che serve alla realizzazione dell’immagine subliminale; gli interventi di Kevin mostrano già una maturità ed una promiscuità tra stile libero e interventi in controtempo.La seconda suite che affianca Periplus è una registrazione live fatta al Pyramid Atlantic Art Center nel novembre del 2014 e si riconduce in terreni più sereni, ricordando le astratte virtù dei musicisti jazz degli anni settanta (Roscoe Mitchell e i suoi gruppi tra i più vicini al sound dei Colla Parte): c’è ancora un flauto convincente in Conticchio e un arco classico in Barbiero che trasportano nella stessa dimensione del periplo: l’esperienza come fattore essenziale di una guida senza tempo.