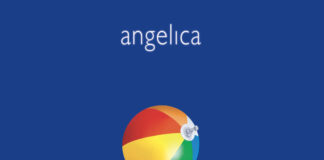Seppur con impostazioni tematiche del tutto singolari, l’attuale interesse del sassofonista Ivo Perelman sembra cristallizzarsi nella ricerca della “giusta” considerazione da attribuire all’improvvisazione. Se dal punto di vista musicale gli ultimi due/tre anni di Perelman lo vedono insistere su un suono di sax quasi equilibrato se raffrontato alla durezza e allo strazio drammatico che ha caratterizzato la sua musica nella sua interezza, dal punto di vista degli argomenti da affrontare c’è una costante intellettualizzazione dei rapporti sinestetici tra la musica e le immagini che dovrebbero scaturire dagli stessi argomenti; Matthew Shipp, che sta oramai abbinando un’ulteriore carriera assieme a Perelman, ha dirottato completamente il sassofonista nella ricerca di una subdola manifestazione di intenti che risponde spesso alla domanda: l’improvvisazione ha una tinta? E se si, quali sono i criteri per creare le corrispondenze tra suoni e colorazioni?
Seppur con impostazioni tematiche del tutto singolari, l’attuale interesse del sassofonista Ivo Perelman sembra cristallizzarsi nella ricerca della “giusta” considerazione da attribuire all’improvvisazione. Se dal punto di vista musicale gli ultimi due/tre anni di Perelman lo vedono insistere su un suono di sax quasi equilibrato se raffrontato alla durezza e allo strazio drammatico che ha caratterizzato la sua musica nella sua interezza, dal punto di vista degli argomenti da affrontare c’è una costante intellettualizzazione dei rapporti sinestetici tra la musica e le immagini che dovrebbero scaturire dagli stessi argomenti; Matthew Shipp, che sta oramai abbinando un’ulteriore carriera assieme a Perelman, ha dirottato completamente il sassofonista nella ricerca di una subdola manifestazione di intenti che risponde spesso alla domanda: l’improvvisazione ha una tinta? E se si, quali sono i criteri per creare le corrispondenze tra suoni e colorazioni?In realtà queste apparenti, semplicistiche affermazioni hanno un substrato teorico molto più ampio, perché investono aspetti di una nuova branca di studi scientifici aurali che si soffermano sull’immaginazione mentale provocata dall’ascolto dei suoni. La percezione di un’immagine non è solo un fattore di natura casuale (di sinesteti della musica la storia ne ha presentati tanti), quanto interessante è individuare una sua oggettività dal punto di vista del tipo formato; immagazzinata in test fatti sugli ascoltatori, mal organizzati dal punto di vista delle locazioni e delle conoscenze le sperimentazioni non riescono ancora oggi a donare un punto di vista univoco su cosa succede esattamente alla nostra immaginazione dinanzi alla fisicità dei suoni; finora quello che si pensa è che la differenziazione delle capacità d’ascolto sia determinante per stabilire le giuste connessioni; ma sarebbe possibile, in costanza di eguale educazione, ottenere un’uniformità erga omnes delle immagini mentali indotte dai suoni?
I tre cds di Perelman si possono confrontare sul terreno delle considerazioni appena accennate: “Complementary Colors“, in duo con Matthew Shipp, è quasi diretto sul tema ed è vittima della parallela occupazione del sassofonista in pittura: le fasce di colore che si vedono in copertina evidenziano una diversità pittorico-musicale dello stile cercato ultimamente da Perelman; il disegno è più ampio, con una densità che il Perelman del passato, espressionista astratto creativamente violento alla Pollock dalle configurazioni a sgocciolo, non sembra offrire. Non c’è lo spasimo e l’eccessiva tensione, ma una voluta tessitura ondeggiante e dissonante che si gioca su tutta la gamma emotiva del sax, con parecchi punti di riferimento nei registri alti dello strumento. L’esperimento di “Villa Lobos Suite”, che lo vede tirannicamente interporsi tra due viole completamente libere ed atonali (Mat Maneri e Tanya Kalmanovitch), è un tentativo di sganciarsi anarchicamente da relazioni retoriche con il compositore brasiliano: non solo non c’è nessun riferimento musicale (la suite è interamente frutto dell’improvvisazione dei tre musicisti), ma addirittura il pensiero va agli string quartets di Carter, di cui afferra il potenziale tecnico senza nessuna somiglianza. La simbiosi tra il brasiliano e l’americano compositore si staglia sull’espressione fornita genericamente dal quartetto d’archi moderno, uno studio sinesteta di una fragranza di gioventù che Perelman ha avvertito durante le improvvisazioni; quel sound amorfo che lega Haydn, Villa Lobos e Carter, è una tinta particolare che può essere sfruttata per svolgere un pensiero improvvisativo. Anche qui la densità delle strutture la fa da padrona, così come una densità emotiva può essere attribuita al trio di “Butterfly Whispers” (con Shipp e Whit Dickey alla batteria), che riprende le nostre riflessioni dal punto di vista della descrizione narrativa tramite anche la dedica al poeta Dila Galvao: “….the titles are just a way of trying to create an atmosphere, like a poetic visual imagery…” (Ivo nelle note del cd); in linea generale su tutti i versanti Shipp non perde un centimetro del fascino del suo pianoforte, così come Dickey si rivela un metodologista della batteria che si integra perfettamente nel contrasto di un’amabile session jazzistica che può essere sicuramente perfezionata.