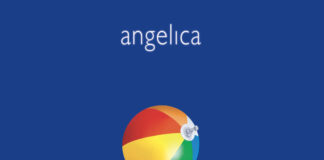Nella parte dedicata al jazz e all’improvvisazione, la HatHut ha ospitato calibri come Paul Bley, Anthony Braxton, Steve Lacy e tanti altri, imponendo un’immagine condivisa tra artisti di interesse internazionale e musicisti svizzeri dello stesso spessore. Per molti anni, discograficamente parlando, parecchio jazz evoluto è passato nei meandri dell’etichetta di Uehlinger (a cui va un ringraziamento senza fine per l’opera svolta) e ancor oggi, le ultime novità pubblicate, rievocano sempre questo principio, imponendo una quantità di risorse selezionate e qualificate nell’ambito del panorama improvvisativo mondiale (la Outhere ha fatto sapere che la produzione si aggirerà tra i 12 e 16 cds all’anno). Qui, perciò, vi presento 4 cds che colgono giovani artisti (unendo svizzeri e non) che proiettano visioni di jazz spinto ai suoi estremi o libere improvvisazione in una forma mentis avanguardista di cui si è sempre nutrita la HatOlogy, l’etichetta svizzera costituita nello specifico dell’improvvisazione.
 Eccellente trombettista, Marco Von Orelli ha dimostrato di condurre un interessante e personale approccio all’improvvisazione. Pur essendo attivo da circa vent’anni, Von Orelli è solo nel decennio scorso che ha cominciato a porsi seriamente in evidenza, passando dall’esperienza della Swiss Improvisers Orchestra a quelle interamente ideate da lui. Notando l’evoluzione progettuale non si può far a meno di affermare che il nuovo cd dal titolo “Blow, Strike & Touch”, prodotto in trio con la sorprendente partecipazione del pianista Max E. Keller (una vecchia conoscenza del mondo musicale contemporaneo, perfettamente in linea con gli intendimenti di Marco) e con la presenza del batterista Sheldon Suter, è il risultato di una ricerca sonora progressiva, compiuta riducendo gli organici (dalla Swiss Improvisers Orchestra si è giunti ai progetti Von Orelli6, poi Von Orelli5, ora il trio). Proprio all’HatOlogy Von Orelli ha trovato la sua dimensione, con eccellenti partners svizzeri e con una propria filosofia che vuole assomigliare molto ad una costruzione “design” della musica. Molta tecnica organica e non convenzionale, liberamente cercata in idiomi solitari o partecipativi, spazio per brevissime soluzioni sotto forma di miniature. Il jazz è presente, naturalmente sotto pelle, e fa capolino ogni tanto con delle linee melodiche, ma sono le configurazioni improvvisative che tengono banco ed intensificano il fascino della registrazione (vedi le caustiche Wideangle o Jagdhund ad esempio, che per la loro sottile ed induttiva sonorità potrebbero indurre al limite anche al rituale).
Eccellente trombettista, Marco Von Orelli ha dimostrato di condurre un interessante e personale approccio all’improvvisazione. Pur essendo attivo da circa vent’anni, Von Orelli è solo nel decennio scorso che ha cominciato a porsi seriamente in evidenza, passando dall’esperienza della Swiss Improvisers Orchestra a quelle interamente ideate da lui. Notando l’evoluzione progettuale non si può far a meno di affermare che il nuovo cd dal titolo “Blow, Strike & Touch”, prodotto in trio con la sorprendente partecipazione del pianista Max E. Keller (una vecchia conoscenza del mondo musicale contemporaneo, perfettamente in linea con gli intendimenti di Marco) e con la presenza del batterista Sheldon Suter, è il risultato di una ricerca sonora progressiva, compiuta riducendo gli organici (dalla Swiss Improvisers Orchestra si è giunti ai progetti Von Orelli6, poi Von Orelli5, ora il trio). Proprio all’HatOlogy Von Orelli ha trovato la sua dimensione, con eccellenti partners svizzeri e con una propria filosofia che vuole assomigliare molto ad una costruzione “design” della musica. Molta tecnica organica e non convenzionale, liberamente cercata in idiomi solitari o partecipativi, spazio per brevissime soluzioni sotto forma di miniature. Il jazz è presente, naturalmente sotto pelle, e fa capolino ogni tanto con delle linee melodiche, ma sono le configurazioni improvvisative che tengono banco ed intensificano il fascino della registrazione (vedi le caustiche Wideangle o Jagdhund ad esempio, che per la loro sottile ed induttiva sonorità potrebbero indurre al limite anche al rituale).
Ciò che emerge è la particolare timbrica che si vuole connettere: Von Orelli propone una tromba cangiante, che sta tra il permaloso e il menefreghismo (frutto di un uso sapiente delle estensioni dello strumento); dal canto suo, Keller mette davanti a tutto l’instabilità pianistica tipica delle conduzioni contemporanee, mentre Suter lavora molto sull’esalazione sonora di piatti e parti percussive della batteria. Tutto conferma la bontà e la riuscita di Blow, Strike & Touch. e invita, ai fini di un raffronto proficuo, ad approfondire musicisti e registrazioni passate.
 Noah Kaplan (classe 1984) è un sassofonista di New York che nasce nel consenso. In un momento come quello attuale, in cui emergere sullo strumento dicendo qualcosa di nuovo è difficile, Kaplan potrebbe essere la risposta giusta, specie se guardiamo al carattere che proviene dalla sua musica. Kaplan si esibisce in maniera tradizionale, di solito con un trio o con un quartetto specifico; quest’ultima è la configurazione che prende vita in Cluster Swerve, secondo cd per la HatOlogy (il primo fu Descendants nel 2011), suonato assieme al chitarrista Joe Morris, Giacomo Merega al basso elettrico e Jason Nazary alla batteria + parti di elettronica.
Noah Kaplan (classe 1984) è un sassofonista di New York che nasce nel consenso. In un momento come quello attuale, in cui emergere sullo strumento dicendo qualcosa di nuovo è difficile, Kaplan potrebbe essere la risposta giusta, specie se guardiamo al carattere che proviene dalla sua musica. Kaplan si esibisce in maniera tradizionale, di solito con un trio o con un quartetto specifico; quest’ultima è la configurazione che prende vita in Cluster Swerve, secondo cd per la HatOlogy (il primo fu Descendants nel 2011), suonato assieme al chitarrista Joe Morris, Giacomo Merega al basso elettrico e Jason Nazary alla batteria + parti di elettronica.
Per introdursi a Cluster Swerve bisogna partire da alcuni riferimenti: innanzitutto perché Cluster Swerve? Come in un soggetto per films, la De rerum natura di Lucrezio qui costituisce lo sfondo principale della linea filosofica del lavoro. La deviazione e il re-incontro casuale degli atomi/corpi che cadono in un vuoto è un tema che iniziò a prendere piede nella Grecia Antica in Epicuro e poi difeso ed ampliato proprio da Lucrezio; sono leggi naturali sul movimento degli atomi che possono essere applicate anche alla musica, basti pensare al clinamen, modalità per poter individuare e scoprire delle relazioni tra i musicisti con diverse prospettive. Cluster Swerve, perciò, tenta di replicare questa scoperta del pensiero, con un’immersione casuale dell’improvvisazione in cui ognuno “devia” dalle regole classiche della musica, ma trova una combinazione nell’incontro del suo operato con gli altri musicisti e, alla fine, determina un “suono” originale. Morris parla di vicinanza a Joe Maneri, anche per il fatto che Kaplan è stato suo allievo, ma è arduo trovare una somiglianza diretta, perché più che una mirata ricerca indirizzata alla stratificazione microtonale o seriale (cercata sui suoni del sassofono o degli altri strumenti), c’è una volontà di portare l’interpretazione e l’esecuzione generale verso l’evocazione di una forma sonora con una qualità emotiva autonoma. Ascoltare le improvvisazioni di Cluster Swerve significa accettare di entrare in congestioni, spazi liberamente creati dai musicisti che si intrecciano secondo un umore definito, specifico: il Clinamen del Kaplan Quartet è un pugno di forzature armonico-ritmiche che si ritrovano magnificamente addensate in un quadro fosco ma affascinante, così come il rifacimento di Body and soul o il blues artefatto di Virago sortiscono auralmente qualcosa di differente rispetto alle analoghe operazioni di recupero svolte da Maneri nei suoi lavori, sono linee melodiche deformate ma non prive di un insperato raccordo alle melodie originarie. E se le irregolarità in appoggio di Merega e Nazary travalicano qualsiasi idea di tenuta ritmica, è la costante esposizione senza tono di Morris che regala il contrasto più forte alle evoluzioni già mature del sax di Kaplan, che oramai merita di acquisire un posto di rilievo nell’attuale scena della giovane improvvisazione statunitense.
 Particolarmente matura si sta facendo anche l’espressione della pianista argentina Paula Shocron (1980). In Tensegridad, un trio con cittadinanza Buenos Aires, formato dal contrabbassista German Lamonega e dal batterista Pablo Diaz (conosciuto anche come LSD Trio), la Shocron si distacca sempre più dal classicismo delle prime proposte per accostarsi definitivamente alle pulsazioni del free jazz e della libera improvvisazione. Con molte pubblicazioni alle spalle ed una attività live non secondaria, compiuta anche nei locali della grande mela grazie agli inviti di Roy Campbell, l’argentina ha cercato di mettere in musica nel migliore dei modi una concezione semplice ed efficace: partire dai modelli (tanti in verità) e affiancare ai loro sentimenti quelli personali. Coadiuvata allo scopo da Lamonega e Diaz, il risultato è inebriante e ciò che viene fuori è un suono profondo e ruspante al tempo stesso.
Particolarmente matura si sta facendo anche l’espressione della pianista argentina Paula Shocron (1980). In Tensegridad, un trio con cittadinanza Buenos Aires, formato dal contrabbassista German Lamonega e dal batterista Pablo Diaz (conosciuto anche come LSD Trio), la Shocron si distacca sempre più dal classicismo delle prime proposte per accostarsi definitivamente alle pulsazioni del free jazz e della libera improvvisazione. Con molte pubblicazioni alle spalle ed una attività live non secondaria, compiuta anche nei locali della grande mela grazie agli inviti di Roy Campbell, l’argentina ha cercato di mettere in musica nel migliore dei modi una concezione semplice ed efficace: partire dai modelli (tanti in verità) e affiancare ai loro sentimenti quelli personali. Coadiuvata allo scopo da Lamonega e Diaz, il risultato è inebriante e ciò che viene fuori è un suono profondo e ruspante al tempo stesso. Del sassofonista Christoph Erb vi ho parlato estesamente in un articolo passato (vedi qui). In quello scritto mancava qualche opinione sul trio formato con gli americani Jim Baker (piano) e Frank Rosaly (batteria); l’occasione me la dà questo nuovo “…don’t buy him a parrot…”, quattro brani estesi in cui con frequenza impressionante si lavora a continue frammentazioni, stop and go architettati in una frazione di secondo, che servono presumibilmente per immedesimarsi nel linguaggio di un canarino, animale che in questo lavoro diventa un protagonista sottaciuto, in relazione ad una vicenda semi-scabrosa intercorsa con Richard Stallman, l’informatico-attivista, propulsore delle licenze libere dei software. La metafora con l’animale funziona musicalmente: Erb ha un gran fiato ed è capace di continue e differenti evoluzioni delle trame, così come dinamici e impeccabili sono i suoi partners nel tessere isole di suoni intorno al suo sax. Erb usa il clarinetto basso all’ingresso di “for canaries, career opportunities in the mining industry“, per smorzare i toni ed esibire ulteriori estensioni del campionario in un clima che ritorna comunque aggressivo nei suoi dodici minuti di densità musicale, grazie alle ventate atonali del piano di Baker e alla fertile indisposizione ritmica di Rosaly. Delle scariche provocate dall’inceppamento volontario delle imboccature in “..it isn’t hard to follow a man who carries a bird cage with him wherever he goes…“, ci avvicinano ancora di più alla simulazione e alla contrapposizione verbale, dandoci l’impressione che, pian piano, diventi una vera espressione.
Del sassofonista Christoph Erb vi ho parlato estesamente in un articolo passato (vedi qui). In quello scritto mancava qualche opinione sul trio formato con gli americani Jim Baker (piano) e Frank Rosaly (batteria); l’occasione me la dà questo nuovo “…don’t buy him a parrot…”, quattro brani estesi in cui con frequenza impressionante si lavora a continue frammentazioni, stop and go architettati in una frazione di secondo, che servono presumibilmente per immedesimarsi nel linguaggio di un canarino, animale che in questo lavoro diventa un protagonista sottaciuto, in relazione ad una vicenda semi-scabrosa intercorsa con Richard Stallman, l’informatico-attivista, propulsore delle licenze libere dei software. La metafora con l’animale funziona musicalmente: Erb ha un gran fiato ed è capace di continue e differenti evoluzioni delle trame, così come dinamici e impeccabili sono i suoi partners nel tessere isole di suoni intorno al suo sax. Erb usa il clarinetto basso all’ingresso di “for canaries, career opportunities in the mining industry“, per smorzare i toni ed esibire ulteriori estensioni del campionario in un clima che ritorna comunque aggressivo nei suoi dodici minuti di densità musicale, grazie alle ventate atonali del piano di Baker e alla fertile indisposizione ritmica di Rosaly. Delle scariche provocate dall’inceppamento volontario delle imboccature in “..it isn’t hard to follow a man who carries a bird cage with him wherever he goes…“, ci avvicinano ancora di più alla simulazione e alla contrapposizione verbale, dandoci l’impressione che, pian piano, diventi una vera espressione.