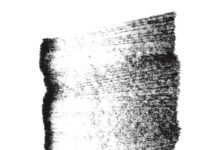Recupero un pò delle ultime pubblicazioni discografiche della Leo Records. Qualche riflessione, d’istinto e di ragione, sulle novità estive dell’etichetta.
 Parto dal ritorno discografico di John Wolf Brennan sotto l’etichetta del gruppo Pago Libre. Got hard è un’esibizione live effettuata all’Alpentone Festival nell’agosto del 2017, esibizione in cui Brennan ha raccolto attorno a sé la Wind Orchestra di Alpentone condotta da Michel Truniger e alcuni musicisti svizzeri della sua generazione (Christy Doran, Patrice Héral e Chistian Zehnder). Lo spettacolo prevedeva brani improvvisati sia nella forma che nel numero dei partecipanti per permettere abbinamenti sontuosi (quelli con l’orchestra), con la recitazione e la danza (con un traditionale scozzese) e un rinverdire le linee musicali del Triangulation group (il trio che Brennan ha impostato con Doran e Héral). Si tratta di qualcosa di cui Brennan sembra vada molto fiero, poiché Got hard è un itinerario consuntivo su quanto fatto dal musicista svizzero negli ultimi vent’anni circa: accantonato il piano solo, Brennan ha insistito molto su un’improvvisazione con molti semi progressivi all’interno, lavorando anche sull’intersezione culturale grazie ai sodalizi fissi con il russo Arkady Shilkloper (presente in questo concerto) e il palestinese Toni Majdalani. E’ questo ampio ventaglio che si apre in Got Hard, conscio di poter mettere assieme una fanfara, un violino perspicace, un trio jazz-rock (a ma/thema/gical fortspinnung), un duetto sopra le nuvole tra corno svizzero e contrabbasso (Lai Nair), un’ilare pantomima, o un camuffamento felice di una Take five (Fake five).
Parto dal ritorno discografico di John Wolf Brennan sotto l’etichetta del gruppo Pago Libre. Got hard è un’esibizione live effettuata all’Alpentone Festival nell’agosto del 2017, esibizione in cui Brennan ha raccolto attorno a sé la Wind Orchestra di Alpentone condotta da Michel Truniger e alcuni musicisti svizzeri della sua generazione (Christy Doran, Patrice Héral e Chistian Zehnder). Lo spettacolo prevedeva brani improvvisati sia nella forma che nel numero dei partecipanti per permettere abbinamenti sontuosi (quelli con l’orchestra), con la recitazione e la danza (con un traditionale scozzese) e un rinverdire le linee musicali del Triangulation group (il trio che Brennan ha impostato con Doran e Héral). Si tratta di qualcosa di cui Brennan sembra vada molto fiero, poiché Got hard è un itinerario consuntivo su quanto fatto dal musicista svizzero negli ultimi vent’anni circa: accantonato il piano solo, Brennan ha insistito molto su un’improvvisazione con molti semi progressivi all’interno, lavorando anche sull’intersezione culturale grazie ai sodalizi fissi con il russo Arkady Shilkloper (presente in questo concerto) e il palestinese Toni Majdalani. E’ questo ampio ventaglio che si apre in Got Hard, conscio di poter mettere assieme una fanfara, un violino perspicace, un trio jazz-rock (a ma/thema/gical fortspinnung), un duetto sopra le nuvole tra corno svizzero e contrabbasso (Lai Nair), un’ilare pantomima, o un camuffamento felice di una Take five (Fake five).L’aural menu, così come lo chiama Brennan, ha tutte le carte in regola per piacere, sebbene non aggiunga nulla a quanto fatto dall’artista fino ad ora; però la sua gioia di vivere è contagiosa quanto la musica che viene espressa.
 Areas è il secondo cd del Gabriela Friedli Trio. Gabriela è una pianista molto intelligente, che sta lavorando ad un possibile sviluppo del trio jazz classico formato da piano-contrabbasso-batteria, senza inflazioni di sorta e cercando di spuntare un pensiero creativo nuovo; in questo compito è notevolmente aiutata dalla prospettiva comune che il contrabbassista Daniel Studer e il batterista Dieter Ulrich dimostrano di avere con lei. La specialità di Areas sta nelle motivazioni, nella ricerca di un suono che, pur avendo una base storica, possa calcare le orme dell’originalità: il passaggio dalle idee ai fatti avviene non facendo ricorso ad un approccio logico, dedito all’interazione o al dialogo improvvisativo, ma soccombendo ad uno strano connubio: su un canone ritmico libero e che in qualche misura si conosce, si inserisce il pensiero della Friedli, che crea strutture frammentate in un canovaccio continuo, mettendo in primo piano la tecnica della pausa. Sono grappoli di note che si infrangono e si ripresentano mentre il tutto resta continua. E’ come se i tre non si sentissero, chiusi nella loro espressione, con la pianista svizzera che snocciola una serie di soluzioni non complete: quasi come sentire Monk o Taylor in una stanza di deframmentazione. Ma i risultati sono eccellenti. Ne deriva, dunque, che Areas è un cd di altissimo livello in tutte le sue parti, perché sa suscitare l’astrattismo del pensiero in maniera perfetta, tramite lo stratagemma della segmentazione e dell’impulso creativo del momento.
Areas è il secondo cd del Gabriela Friedli Trio. Gabriela è una pianista molto intelligente, che sta lavorando ad un possibile sviluppo del trio jazz classico formato da piano-contrabbasso-batteria, senza inflazioni di sorta e cercando di spuntare un pensiero creativo nuovo; in questo compito è notevolmente aiutata dalla prospettiva comune che il contrabbassista Daniel Studer e il batterista Dieter Ulrich dimostrano di avere con lei. La specialità di Areas sta nelle motivazioni, nella ricerca di un suono che, pur avendo una base storica, possa calcare le orme dell’originalità: il passaggio dalle idee ai fatti avviene non facendo ricorso ad un approccio logico, dedito all’interazione o al dialogo improvvisativo, ma soccombendo ad uno strano connubio: su un canone ritmico libero e che in qualche misura si conosce, si inserisce il pensiero della Friedli, che crea strutture frammentate in un canovaccio continuo, mettendo in primo piano la tecnica della pausa. Sono grappoli di note che si infrangono e si ripresentano mentre il tutto resta continua. E’ come se i tre non si sentissero, chiusi nella loro espressione, con la pianista svizzera che snocciola una serie di soluzioni non complete: quasi come sentire Monk o Taylor in una stanza di deframmentazione. Ma i risultati sono eccellenti. Ne deriva, dunque, che Areas è un cd di altissimo livello in tutte le sue parti, perché sa suscitare l’astrattismo del pensiero in maniera perfetta, tramite lo stratagemma della segmentazione e dell’impulso creativo del momento. Con esperienza nei gruppi dei Westbrook inglesi, la sassofonista altista Roz Harding si presenta all’esordio da leader con un trio accorto di chitarra elettrica e batteria (Mike Outram e Jim Bashford). La Harding ha registrato Supermood, che negli intenti dovrebbe riferirsi a qualcosa che amplifica gli umori, quantomeno ci tenta attraverso i suoni. Tuttavia, per sgomberare subito le idee fuorvianti dirò che non siamo di fronte ad operazioni di quelle alla Colin Stetson, anche perché la Harding non possiede quelle capacità; qui è il jazz tipico delle lande inglesi anni settanta che fa capolino, estroso e scattante, con qualche sprazzo di diversità durante il percorso. Se non si può dir nulla sulla bravura dei musicisti, riesce difficile tenere banco con gli argomenti, poiché purtroppo nella tonalità jazz e rock, anche in compresenza improvvisativa, mi sembra che siano realmente nulli gli spazi di manovra. In tal senso, faccio fatica a trovare musicisti che non siano edulcorati ritorni del passato. Perciò l’elemento novità è totalmente da sviluppare per il futuro.
Con esperienza nei gruppi dei Westbrook inglesi, la sassofonista altista Roz Harding si presenta all’esordio da leader con un trio accorto di chitarra elettrica e batteria (Mike Outram e Jim Bashford). La Harding ha registrato Supermood, che negli intenti dovrebbe riferirsi a qualcosa che amplifica gli umori, quantomeno ci tenta attraverso i suoni. Tuttavia, per sgomberare subito le idee fuorvianti dirò che non siamo di fronte ad operazioni di quelle alla Colin Stetson, anche perché la Harding non possiede quelle capacità; qui è il jazz tipico delle lande inglesi anni settanta che fa capolino, estroso e scattante, con qualche sprazzo di diversità durante il percorso. Se non si può dir nulla sulla bravura dei musicisti, riesce difficile tenere banco con gli argomenti, poiché purtroppo nella tonalità jazz e rock, anche in compresenza improvvisativa, mi sembra che siano realmente nulli gli spazi di manovra. In tal senso, faccio fatica a trovare musicisti che non siano edulcorati ritorni del passato. Perciò l’elemento novità è totalmente da sviluppare per il futuro. Di tutt’altro spessore è The last taxi: in transit, lavoro che proviene da una formazione di musicisti americani e cantanti italiane, guidata dal pianista Pat Battstone. L’input è venuto da un suo viaggio in Puglia, grazie alla conoscenza del pool degli improvvisatori di spicco dell’area barese e leccese, con cui Battstone ha inciso anche altri cds. Per la Leo, l’unione viene materializzata fra il pianista americano, due cantanti pugliesi (Gianna Montecalvo e Antonella Chionna) e 4 musicisti americani che completano l’organico. Tra frequentazioni, voli tra Bari e New York e una percezione millimetrica del progetto da intraprendere, si è tirato fuori un lavoro completo, assolutamente di valore e di classe al tempo stesso, in cui Battstone e gli strumentisti sorreggono strutture jazz o libere trovando il pieno completamento nell’espressione delle due cantanti: basterebbe ascoltare la sensazione provocata all’apertura As the city awakens, un pezzo che invoca un risveglio mattutino che musicalmente diventa prezioso con le sortite vocali della Montecalvo e della Chionna. C’è un campionario di tecniche vocali e sensibilità artistica in The last taxi: in transit, che si estrinseca non solo con una saldatura alle evoluzioni degli strumenti, ma si materializza con scat vibranti, tentativi di estasi alla Winston, figure libere, congestioni e fonologie alla Phil Minton, simulazioni operistiche e mediazioni verbali, sviluppi drammaturgici e jazz. E’ un obbligo l’ascolto di brani come Creatures of the night forest (le creature notturne emergono con molta perspicacia) o Immigrant song (un equilibrio perfetto della sovrapposizione), in un contesto in cui flauto, vibrafono e contrabbasso lavorano con vibrazioni calcolate per indurre la reazione simulatoria e free delle cantanti. A livello di improvvisazione vocale è certamente la cosa più interessante che è stata prodotta in questo 2018.
Di tutt’altro spessore è The last taxi: in transit, lavoro che proviene da una formazione di musicisti americani e cantanti italiane, guidata dal pianista Pat Battstone. L’input è venuto da un suo viaggio in Puglia, grazie alla conoscenza del pool degli improvvisatori di spicco dell’area barese e leccese, con cui Battstone ha inciso anche altri cds. Per la Leo, l’unione viene materializzata fra il pianista americano, due cantanti pugliesi (Gianna Montecalvo e Antonella Chionna) e 4 musicisti americani che completano l’organico. Tra frequentazioni, voli tra Bari e New York e una percezione millimetrica del progetto da intraprendere, si è tirato fuori un lavoro completo, assolutamente di valore e di classe al tempo stesso, in cui Battstone e gli strumentisti sorreggono strutture jazz o libere trovando il pieno completamento nell’espressione delle due cantanti: basterebbe ascoltare la sensazione provocata all’apertura As the city awakens, un pezzo che invoca un risveglio mattutino che musicalmente diventa prezioso con le sortite vocali della Montecalvo e della Chionna. C’è un campionario di tecniche vocali e sensibilità artistica in The last taxi: in transit, che si estrinseca non solo con una saldatura alle evoluzioni degli strumenti, ma si materializza con scat vibranti, tentativi di estasi alla Winston, figure libere, congestioni e fonologie alla Phil Minton, simulazioni operistiche e mediazioni verbali, sviluppi drammaturgici e jazz. E’ un obbligo l’ascolto di brani come Creatures of the night forest (le creature notturne emergono con molta perspicacia) o Immigrant song (un equilibrio perfetto della sovrapposizione), in un contesto in cui flauto, vibrafono e contrabbasso lavorano con vibrazioni calcolate per indurre la reazione simulatoria e free delle cantanti. A livello di improvvisazione vocale è certamente la cosa più interessante che è stata prodotta in questo 2018. Penso che di Carol Liebowitz, pianista e cantante newyorchese, si sappia ben poco oltre gli ambienti specialistici: con un background solido che rimanda molto ad una delle sue insegnanti (la Connie Crothers), l’artista americana ha inciso parecchio negli ultimi anni e anche la Leo R. coglie questa interessante occasione di scoprire il suo talento. Malita-Malika è un duetto con Birgitta Flick, sassofonista tenore dalle tinte calde, soffuse e prolungate, con un soffio tipico che richiama altri tempi (Webster, Young); tutto però si sviluppa magnificamente in questa collaborazione, dando origine ad un flusso creativo impressionistico ed astratto quanto basta, che regala, oltre ad un’atmosfera piena di sentimento non retorico, anche un paio di rivisitazioni particolarmente riuscite: si tratta di Marionette, un pezzo del chitarrista Billy Bauer, che viene unito a September in the rain, dove compare la vocalità tutta da assaporare della Liebowitz, e di You don’t know what love is, lo standard di De Paul & Raye. Un esempio di cosa si può ancora fare con l’armonia, con la sua logica che può far apparire l’incertezza e il sogno contemporaneamente.
Penso che di Carol Liebowitz, pianista e cantante newyorchese, si sappia ben poco oltre gli ambienti specialistici: con un background solido che rimanda molto ad una delle sue insegnanti (la Connie Crothers), l’artista americana ha inciso parecchio negli ultimi anni e anche la Leo R. coglie questa interessante occasione di scoprire il suo talento. Malita-Malika è un duetto con Birgitta Flick, sassofonista tenore dalle tinte calde, soffuse e prolungate, con un soffio tipico che richiama altri tempi (Webster, Young); tutto però si sviluppa magnificamente in questa collaborazione, dando origine ad un flusso creativo impressionistico ed astratto quanto basta, che regala, oltre ad un’atmosfera piena di sentimento non retorico, anche un paio di rivisitazioni particolarmente riuscite: si tratta di Marionette, un pezzo del chitarrista Billy Bauer, che viene unito a September in the rain, dove compare la vocalità tutta da assaporare della Liebowitz, e di You don’t know what love is, lo standard di De Paul & Raye. Un esempio di cosa si può ancora fare con l’armonia, con la sua logica che può far apparire l’incertezza e il sogno contemporaneamente.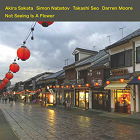 Registrato live durante un tour fatto in Giappone, l’ultimo cd di Simon Nabatov è un quartetto con l’illustre Akira Sakata, Takashi Seo al contrabbasso e Darren Moore alla batteria. Not seeing is a flower è un bel connubio tra il russo e Sakata soprattutto, perché porta sullo stesso piano i due stili, nettamente differenziati dei due musicisti. Da una parte il veloce, imprevedibile, libero e classico sciorinare sul piano di Simon, dall’altra le sferzate rough (meno abrasive del solito, a dire il vero) e le invenzioni narrative in real time del sassofonista giapponese. I sei pezzi sono pensati forse per una rappresentazione di free improvisation che proietta l’essenzialità dell’esplorazione sensitiva: si va per jams che cercano di sondare un costante smantellamento e ricostruzione degli umori; un modo per ripresentare idee che non disturbano ma che non vanno oltre l’energia solitamente attribuita a questi lavori, alla fine lasciandoci pretendere qualcosa in più del sentito.
Registrato live durante un tour fatto in Giappone, l’ultimo cd di Simon Nabatov è un quartetto con l’illustre Akira Sakata, Takashi Seo al contrabbasso e Darren Moore alla batteria. Not seeing is a flower è un bel connubio tra il russo e Sakata soprattutto, perché porta sullo stesso piano i due stili, nettamente differenziati dei due musicisti. Da una parte il veloce, imprevedibile, libero e classico sciorinare sul piano di Simon, dall’altra le sferzate rough (meno abrasive del solito, a dire il vero) e le invenzioni narrative in real time del sassofonista giapponese. I sei pezzi sono pensati forse per una rappresentazione di free improvisation che proietta l’essenzialità dell’esplorazione sensitiva: si va per jams che cercano di sondare un costante smantellamento e ricostruzione degli umori; un modo per ripresentare idee che non disturbano ma che non vanno oltre l’energia solitamente attribuita a questi lavori, alla fine lasciandoci pretendere qualcosa in più del sentito.Al prossimo articolo commenterò i due nuovi cds per Leo di Ivo Perelman.