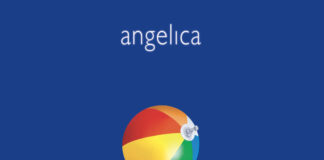Su queste pagine, scrivevo tempo fa in un saggio sul post-rock: “…questa nuova logica di gruppo aveva una chiarissima motivazione: rifletteva la catarsi che la musica (ed anche il rock) stava attraversando; i musicisti si stavano impegnando nell’uso drammaturgico della musica, che doveva trasmettere una imperterrita inquietudine (quella dei tempi vissuti). E’ uno dei momenti storici in cui nel rock viene esaltata l’epicità, come in una bella descrizione di una poesia greca…” (estratto da qui).
Tra questi nuovi poeti, trasfusi nel settore musicale e vissuti a fine novecento, non potevi fare a meno di includere Mark Hollis. A differenza di tanti artisti che trovano subito il riconoscimento nelle opere prime, Hollis lò trovo un pò più tardi. Il cantante inglese maturò un veloce cambiamento musicale, passando progressivamente per tre stadi di genere: synth-pop/rock di influenze/essenza post-rock; pochi, a livello critico, avrebbero scommesso su Hollis e sul suo gruppo (i Talk Talk), specie nel periodo di Such a shame, poiché nel synth-pop di quegli anni era decisamente possibile trovare espressioni migliori, ma l’illuminazione arrivò con Spirit of Eden, che rappresentava un atto di completamento, in un processo di rifiuto dei canoni della pop song così come si era sviluppata fino ad allora. In Spirit of Eden, vere e proprie condensazioni profonde del pensiero vengono esplicitamente accompagnate ad una musica che pescava da alcune geniali combinazioni musicali del passato: la tromba introduttiva al tema di Miles Davis, gli spazi “praterici” delle chitarre di Crosby e del suo If I could only remember my name, l’armonica guizzante e gelida dei suonatori di blues, gli arrangiamenti classici degli impressionisti; Hollis ristabiliva un contatto, apportando un proprio fraseggio, qualche effetto strumentale-produttivo azzeccato (la collaborazione con il produttore Timothy Alan Friese-Greene si estendeva anche al testo), un falsetto particolarmente incisivo, naturalmente drammatico e, come detto, la sua poesia, una porta aperta su una tipologia di modernismo poetico, che valse l’inclusione dei suoi testi in riviste blasonate di letteratura come Chiron Review e Opossum. In Spirit of Eden si fa avanti un’organizzazione di mezzi e finanche uno spirito del cantare: da una parte il lavoro tiene dentro tutti gli strumenti (c’erano anche dobro, percussioni, contrabbasso, violino, fagotto, oboe, clarinetto, corno inglese, basso messicano, shozyg e persino il coro fanciullesco della cattedrale di Chelmsford), dall’altra, il canto si spinge talvolta ai confini dell’etereo, cominciando ad evidenziare quelle perdite di tono che saranno poi applicate come sostanza slo-core.
Tre anni dopo, Laughing stock si presenta come ancor più indispensabile, convogliando la latente disperazione del poeta nelle intelaiature tecniche del post-rock: aumentano i riverberi, gli arrangiamenti sono più intriganti, gli effetti scavano, la batteria picchia in tempi non convenzionali; è qui che si può ascoltare una versione completamente aggiornata del diluvio alla Dylan, anche qui un post e non un ante (la Before the flood di Dylan si trasforma in un After the flood) e scorgere i semi produttivi dell’Happy sad di Tim Buckley nel sussurro condotto in Taphead. E’ un processo di confluenza che si perfezionerà nel suo album solista, arrivato sette anni dopo Laughing stock e che purtroppo segna l’ultima comparsa discografica dell’artista inglese (1998).
Le canzoni di Hollis sono preghiere, inni alla vita di personaggi depressi e pensanti, piccoli saggi musicali che si ascoltano nei momenti di riflessione, quando ci prende il magone dell’insicurezza del dover vivere: i suoi messaggi intelligenti entrano in sintonia con lo spazio dedicato alla musica, tant’è che Hollis proponeva persino un rispetto dell’ambiente d’ascolto; il suo è stato un raccordo delle tinte, oltre a quello generazionale, qualcosa che potesse far brillare di lucentezza l’oscurità del nostro cammino cosciente.