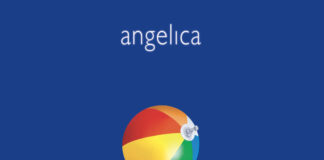Se si affronta la composizione contemporanea per duo di violini, ci si accorge come nel Novecento essa sia stata quantitativamente scarsa e incapace di fondare esecutori stabili, ossia violinisti alla caccia di un repertorio scavato per loro. Uno dei primi tentativi di estorcere i consueti impianti armonici e melodici fu fatto da Paul Hindemith nel 1931 nell’ambito della costruzione dei suoi duetti seriali di Kanonisches Vortragsstuck und kanonische Variationen, ma probabilmente un decisivo argomento a favore di un cambio di rotta furono le Seven Sonatas di Allan Pettersson, scritte nel 1951 ma riscoperte solo nei novanta grazie alla veemente riconsiderazione di un duo per violini svedese-tedesco, i coniugi Cecilia e Martin Gelland.
Il Duo Gelland ristabilì la corretta visuale su un tipo di approccio, intervenendo sul repertorio esistente non in maniera casuale (la pratica di accordare due violinisti per un pezzo musicale era estemporanea, non legata ad un vincolo di lavoro stabile), creando le premesse per un innalzamento dei valori e delle interpretazioni; l’attività del duo ha avuto un largo raggio d’azione ma è nella parte nordica dell’Europa (Svezia soprattutto) che i due violinisti hanno costruito un ampio repertorio, debitamente registrato (segnalo per loro i 6 volumi di Violin Duos, in cui si viene colpiti dalla bellezza delle esecuzioni dei pezzi di Erik Forare o Birgitte Alsted, ma anche la registrazione della Sinfonia per due violini del compositore Fredrik Hagstedt).
Allo stato attuale delle cose, il Duo Gelland è uno dei rarissimi esempi di violinisti classici capaci di relazionarsi con qualsiasi altro terreno interdisciplinare: pur essendo la musica classica il loro core business, non si escludono le capacità riversate sull’improvvisazione, sulla gestualità e la danza; duetti contemporanei simili, anche se limitati nel campo d’azione profuso, sono sorti in Inghilterra con i Retorica (le due violiniste Mo e McKenzie), negli Stati Uniti con Jameson Cooper e James Dickinson (che si sono adoperati nell’interpretazione moderna di Spohr) e in Germania con l’An-Hang Violins (Anja Gaettens e Wen-Hang Chang).
L’ultima pubblicazione del Duo Gelland prende in considerazione la via italiana del duo violinistico contemporaneo: sull’argomento autori come Scelsi (Arc-en-ciel del 1973), Berio (i Duetti del 1983) o Nono (Hay que caminar, soñando del 1989) hanno testimoniato l’importanza di un famelico assorbimento degli scopi compositivi, in cui gran parte del risultato finale è l’effetto di uno scambio simbiotico con i suoni o le costruzioni armoniche. Il principio è che non esistono due momenti uguali nello sviluppo interpretativo del brano, circostanza che indirettamente porta anche ad una possibile rivisitazione di spazi musicali non coperti originariamente dai violini: ecco che allora si giustifica l’inserimento nel repertorio di Serenata per un satellite, il celebre pezzo di Bruno Maderna scritto nel 1969, che ha avuto fortuna in altre combinazioni strumentali; il Duo Gelland ne estrapola l’essenza, quel roteare gli strumenti in modo da governare la nuvola di suoni che si crea intorno e stacca sulle abitudini d’ascolto di un pezzo che abbiamo imparato a memorizzare in maniera differente (Maderna lasciava all’arbitrio dei musicisti la sequenza dei frammenti scritti in una partitura creativa, con i pentagrammi legati in cerchio, obliqui o ricurvi); ad esempio, il motivo che influisce su una figura veloce o un pianissimo subisce un altro trattamento timbrico sui violini, il che crea nuove situazioni, che godono di una loro libertà espressiva. E’ un modo di rigenerare il violinismo veneziano, rispettoso del carattere arioso ed aperto della scuola (da Gabrieli a Vivaldi) ma che è anche fagocitare i tempi grazie al suo moto complesso e tensivo. La via veneziana viene ulteriormente corroborata in Hay que caminar, soñando di Luigi Nono, l’ultima composizione che egli scrisse prima di morire: qui la complessità del pezzo, determinata da un raffinatissimo sistema di sfumature sui registri e sulle intensità, è cucita in una ricerca di trascendenza, elemento che sta esattamente all’opposto di quanto cercato da Maderna nella sua Serenata, totale estrinsecazione di coefficienti del vissuto; tra le versioni disponibili e trasferite in una registrazione quella di Irvine Arditti e David Alberman è un riferimento primario in quanto essa è in possesso di una capacità di dettaglio e di una resa sonora che riesce ad evidenziare perbene l’utopia del “cammino” di Nono, riposta nella musica; bene, quella del Duo Gelland riesce non solo ad eguagliare quella degli inglesi (il che non è già poco!) in compiutezza dell’esecuzione, ma la supera in termini di dinamiche equilibrate dei suoni, soprattutto sulle alte frequenze. In tal modo consente un aumento di quell’area cognitiva del lavoro che tende allo sconfinamento spirituale: nella splendida composizione di Nono c’è una confluenza di elementi misteriosi fuori da qualsiasi ideologia precostituita, dalla scala enigmatica (la scala di Crescentini del 1888 dalla singolare ed impalpabile risoluzione) alla serie di Fibonacci, che ancora oggi meritano un discernimento.
La terza composizione in esame è inoltre, composizione di Giorgio Netti terminata nel 2006: pur non essendo un veneziano, Netti si inserisce nella grande tradizione filosofica di quella scuola violinistica, ristabilendo un contatto concreto con essa, basato sul temperamento e sulle attenzioni estensive che scrutano gli strumenti; la partitura è tesa a scovare zone poco esplorate dei violini, con preparazioni e strategie che tendono a rivalutare la maestria tecnica ed emotiva dei veneziani: “…è l’esperienza di un’energia che da sempre già abita il violino e, di soglia in soglia, continuamente si trasforma… l’energia che abita i violini di Corelli, Tartini, Vivaldi, certo non citazioni ne dirette ne indirette ma l’imprevedibile vitalità delle loro articolazioni (tremoli, arpeggi, ribattuti, sincronie e fioriture improvvise) che hanno fatto della scuola italiana, elettrica ante litteram, un irraggiungibile modello di virtuosismo strumentale; poi la tensione, il vuoto attorno e dentro alla costruzione delle frasi, le imitazioni, i pedali, la continua sovrapposizione delle corde…” (dalle note di presentazione del compositore).
inoltre ha avuto una gestazione importante tra il Duo Gelland e Netti, oltre 17 minuti che propongono un meraviglioso camuffamento dei tempi: un’ottica in possesso di una sua celata drammaturgia, che deriva forse da una cultura del lamento o dell’avvertimento filosofico, ma che si snoda attraverso tutte le scoperte estensive che i due violinisti sono in grado di far emergere dai loro strumenti. Microtonalità in primo piano, anche frammentata, con variazioni ritmiche continue, cariche di sorprese, ed una propensione all’estrazione noise: nel caso specifico due grossi blocchi compositivi dalla coerente natura subliminale, uno che sembra replicare le manovre di utilizzazione di un ordigno, l’altro che introduce un saliscendi o forse la replica di un motore di un’auto o di un macchinario con le sua accelerazioni o decelerazioni. inoltre cerca di svelare l’antico utilizzando mezzi attuali: come succede in tutta la visuale poetica di Netti, l’approfondimento corporale e sonoro dello strumento è un modo per scoprire la sua indole storica, qualcosa che non è venuta a galla mai prima d’ora; se si pensa che la rinascita di una sensazione sulla materia dei due violini possa essere più generalizzata, bisognerà ammettere che un punto di ripartenza necessario è quanto attuato da Netti e che l’interpretazione minuziosa del Duo Gelland sia la realizzazione plausibile di soluzioni ricavabili da un universo di suoni, parametrate alla forza acustica dei violini.
Con il permesso di Giorgio, mi permetto di riportare un passo di un lungo scritto che è il risultato di una corrispondenza tra il compositore ed il suo amico scultore Federico De Leonardis (l’intero testo è liberamente consultabile qui): il motivo è che esso consente di comprendere come inoltre sia un tentativo di proporre un ben definito linguaggio all’interno di quella infinita griglia di combinazioni umorali determinata dall’utilizzo delle estensioni. Lachenmann, Sciarrino e molti altri compositori hanno gettato i primi sassi nel mare della scoperta estensiva, ma lo spazio di conquista è lontano dal darci soluzioni finite ed esaustive; soprattutto si può affermare che ogni compositore dispone di manovre più che sufficienti per costruire una propria leggibilità estetica e musicale.
FDL: Dico evidentemente visto il risultato, ma il rumore è così evidentemente presente in tutte le varie sequenze che fino alla fine si dubita che il pezzo sia composto. Non so se questo sia uno scopo della tua poetica…
GN: Il rumore è abitualmente considerato in musica un po’ come la tenebra del suono: da nascondere ed evitare pena la perdita della cosiddetta purezza. In questa purezza, di (apparente) derivazione romantica e quindi relativamente recente e confinata ad un breve periodo nella storia complessiva della musica tutta, si raccoglie l’idealismo disincarnato di una potente e articolatissima teologia sotterranea che ancora oggi, soprattutto oggi, avvelena i suoi adepti.
E’ una purezza intesa come principale proiezione del divino patristicamente organizzato, una cubica astrazione a tavolino, inibitrice di tutto ciò che invece era ed è corpo e materia; un assoluto impraticabile e quindi irraggiungibile, che deprezza e oscura ogni gesto nato per fare concretamente qualcosa di meno condizionato. Questa purezza è stata affilata per spaccare in blocchi contrapposti, bene-male, bello-brutto, sano-malato, …musica-rumore): è l’arma più efficace del potere in quanto filigranato copyright di una proprietà capillarmente imposta e sorvegliata. Foucault ne ha già detto abbastanza. Altra cosa è la purezza che unisce: una purezza relativa, il cui valore comprendiamo se già siamo personalmente coinvolti nella ricerca di una maggiore indipendenza; una ricerca senza tempo che, con il suo ostinato interrogare le barriere che ci separano da una realtà più ampia, diagonalmente attraversa tutte le culture. Per non confonderla con la prima si potrebbe forse chiamarla trasparenza, parola in cui è compresa un’infinità di valori intermedi, nessuno dei quali nega la presenza della luce.
Nella Farbenlehre al punto 69, riferendosi alle ombre colorate Goethe dice che il colore è un valore d’ombra; il senso di questa affermazione non è mi è mai stato chiaro ma la sua enigmaticità ha irradiato attorno a me negli anni, un’area di “sfumate” metafore della vicenda artistica/umana. Interpreto: il colore (dell’ombra) è determinato dalla specificità del corpo (semitrasparente) frapposto tra la fonte di luce e la qualità del piano sul quale si proietta la sua ombra; è un valore intermedio fra la completa opacità di un corpo e la sua totale trasparenza alla luce; il colore dunque è la proiezione, su un piano, del passaggio della luce attraverso un filtro specifico: una luce interpretata, che solo per il fatto di esser stata interpretata è, visibile. Poi proseguo, “il timbro è un valore d’ombra” e più in là “l’uomo è un valore d’ombra”, per azzardarmi a dire che il concetto stesso di valore deriva dalla interpretazione di un filtraggio avvenuto. Ciò che più mi sembra interessante in tutti i campi è incrinare l’abituale automaticità dell’interpretazione, automaticità che nega il concetto stesso di interpretazione per limitarsi a quello di convenzione presuntuosamente chiamata “realtà”. Sarà dunque attraverso la consapevolezza dei filtri applicati che i contrasti, le certezze, le irriducibili opposizioni ideali si apriranno verso mondi non solo intermedi ma altri, nuove dimensioni che solo uno sguardo/ascolto/linguaggio approssimativo considera ancora “irreali”.
Sarebbe necessario a questo punto definire cosa intendo per filtro e per sistema di filtri, ma soprattutto a cosa si relaziona la sua presunta qualità: essendo interessato all’energia originaria che ha generato la specificità di ogni strumento, la qualità del filtro sarà per me, dal lato intuitivo, in relazione alla maggiore o minore libertà di accesso a quella energia, da quello progettuale, in relazione alla generatività espressiva che sarà in grado di sostenere, vale a dire alla sua potenza interpretativa..
L’inscatolamento e la mercificazione di Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin ecc. hanno alimentato una versione soffocata e impotente di quella tensione originaria che per la prima volta (con un coraggio negato agli attuali, non amanti ma, guardoni del romanticismo) puntò dritta verso la propria verità. Tutto era tranne che un’arte limpida e distaccata. Non nell’impurità generica ma nel suo specifico colore invece, nell’esatta alterazione, nella particolarità, nell’eccezione ostinatamente indagata, quegli autori trovarono le chiavi personali per aprire la barriera di convenzioni che nuovamente impedivano l’ascolto, quello vero.
Tutte le tradizioni musicali (compresa la nostra) hanno un rapporto con il cosiddetto rumore ben più complesso e vitale; buona parte delle tradizioni extra europee non ha nemmeno una parola specifica per musica, perché non separa il pezzo dagli strumenti che lo suonano, dai musicisti, dagli eventuali danzatori, dal contesto che tutto questo ha generato; così come quasi mai esiste un ascolto passivo della musica e quindi una netta separazione fra musicisti e pubblico nonostante dappertutto ci siano anche musicisti professionisti. La musica ha sempre avuto uno spazio quotidiano nella vita di tutti, a contatto con la vita di tutti, accogliendo umori e rumori di ogni tipo, sia negli strumenti stessi (la cui infinita varietà testimonia della specificità di ogni singola scelta) che nelle modalità esecutive. La selezione tardo ottocentesca in funzione di un’omogeneità dell’orchestra è solo un frammento dell’immensa memoria strumentale: una standardizzazione artigianale che da un lato ha permesso di spingere il pensiero formale verso un’ampiezza ad altre tradizioni sconosciuta, dall’altro ha quasi interrotto (nel contesto classico) il processo di trasformazione continua che sempre ha caratterizzato la vitalità intrinseca ad ogni strumento. La morte di uno strumento sta proprio nella sua omologazione totale, cioè nella sua simulazione attraverso computer, soprattutto là dove il risultato è definito dai più, perfetto. Lo strumento così decapitato della sua profondità diventa un numero del “protocollo di comunicazione midi“ (musical instrument digital interface) e la definizione tecnica già dice tutto. Questo tecnologico “off” è però il risultato di un processo che ha avuto il suo avvio proprio nella progressiva omologazione di ciò che, dal punto di vista pretestuosamente classico, è considerato strumento e musica.
Nella direzione opposta, invece, troviamo uno strumento e il suo uso così specifici da essere completamente insostituibili.
Nel jazz ad esempio: il musicista che conta e il suo strumento sono un unicum distinguibile fra migliaia di simili; poi nel rock e tutti i suoi derivati, l’elettrificazione di chitarra e contrabbasso che ha praticamente inventato due nuovi strumenti associandoli ad un terzo che fosse in grado di sostenerne l’impatto dinamico, la batteria, dando vita a un genere musicale nuovo che ha quasi completamente re-interpretato la funzione sociale stessa della musica. Pensa a che parte fondamentale ha il cosiddetto rumore in entrambe, definito rumore appunto solo da chi non le ha mai veramente ascoltate: in questo senso penso che la distinzione fra suono e rumore sia soprattutto una questione di contesto, come dicevo prima “di filtro d’ascolto” o, ancora più a fondo, “di sordità difensiva”. Pensa anche a tutta l’arte contemporanea che ha aggirato lo strapotere dell’incorniciabile e del bronzo entrando a fondo nella specificità di ogni materiale comune per cavarne, così come i michelangelo dal marmo, la sua forza. Tutti i materiali che popolano il nostro quotidiano sono diventati così potenziali parabole di poesia che attende di essere decodificata; ma per i più rimangono res nullius, se mai res a parte il soldo abbia avuto mai valore per gli stessi.