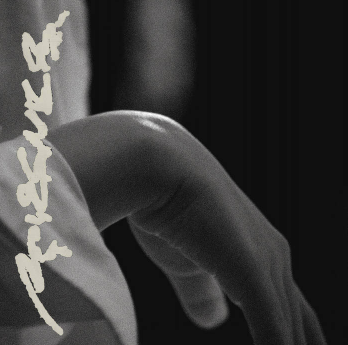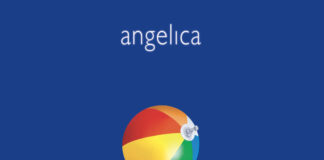Recensione originariamente pubblicata su esoteros, courtesy l’autore.
Disse John Cage che «i dischi rovinano il paesaggio», vale a dire tradiscono o addirittura snaturano l’essenza dell’accadimento sonoro così come esso si dà nell’immediato (non-mediato). Un punto di vista radicale e per certi versi inconfutabile, ma che in rapporto all’ascolto privato, differito nel tempo, può essere facilmente capovolto: così anche il “paesaggio”, l’insieme dei fondamenti concettuali, tecnici e performativi, molto spesso distoglie l’attenzione da ciò che si sperimenta a un livello puramente uditivo, persino una volta che l’opera musicale sia stata fissata definitivamente su un supporto fisico o digitale.
Con ciò non si intende minimizzare in alcun modo la stratificata complessità che contraddistingue la visione multidisciplinare di Pan Daijing, talentuosa artista cinese presa sin dagli esordi sotto l’ala di Bill Kouligas e della sua influente etichetta PAN: se tuttavia il progetto originario di Tissues, presentato alla Tate Modern di Londra nel 2019, rimane un punto focale isolato, non più esperibile nella sua integrale pregnanza audiovisiva, la presente iterazione ne mantiene vivo il potere di suggestione a tal punto da qualificarsi pienamente in quanto opera, drammaturgia autonoma e in sé compiuta, persino al netto di qualsiasi valenza simbolica od intento rappresentativo. Come a dire che ogni album è una sorta di teatro assente, il proscenio buio sul quale possono agire soltanto entità acusmatiche inconoscibili.
Con questa sola predisposizione mentale è consigliabile accostarsi all’atavico dominio espressivo cui Daijing attinge proficuamente, un’era remota in cui si poteva ancora toccare con mano il trascendente, scrutare a occhi spalancati l’orizzonte ideale dell’eterno. Composto per coro a quattro voci ed elettronica, in Tissues si delinea ancora una volta un rituale dove la fragilità umana tenta di avvicinare l’ineffabile, la parola si avviluppa in refrain mantrici volti all’abbandono della significazione.
Le dense campiture sintetiche – assieme a certe sequenze dai netti rintocchi di pianoforte – ne divengono il cantus firmus, il solido innesto attorno al quale le armonie si estendono rigogliose, giungono a perfetta e lucente concordanza (“A Found Lament”) per poi sfaldarsi in rapide traiettorie divergenti, un saettare di cellule atonali che mancano di collidere l’una con l’altra (“A Tender Accent”).
Non di rado la spessa grana delle onde sinusoidali si spinge sino ai confini del rumore bianco, pervade con insistenza lo spazio acustico e insidia l’equilibrio delle parti corali: le loro elevazioni liriche echeggiano a fasi alterne il Philip Glass di “Akhnaten” e i fonemi sincopati di Meredith Monk, tracce di una solennità primordiale e incorrotta dispersa dalle correnti del tempo. Ed è in questa sostanziale estraniazione dalla contingenza storica e culturale – nonostante l’adozione del linguaggio elettronico e il cruciale ruolo dialettico da esso rivestito – che risiede l’essenza irriducibile dell’opera di Pan Daijing, spogliata della corporeità performativa per tramutarsi qui in una mirabile coreografia dell’animo.