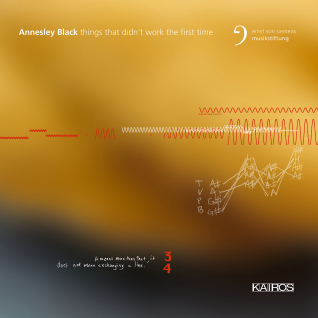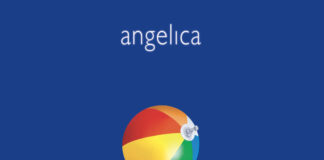Recensione originariamente pubblicata su esoteros, courtesy l’autore.
Storicamente parlando, l’ansia di comunicare ha sempre (benché forse involontariamente) squalificato le peculiarità del linguaggio sonoro – che, di fatto, linguaggio non è. Eliminare i costrutti e le costrizioni concettuali dal processo creativo offre un accesso privilegiato al potere assoluto, non sollecitato, che la musica è in grado di esercitare sull’immaginazione di chi è disposto ad ascoltarla. Ecco donde ha origine il fascino inusitato, finanche alieno, delle fantasie cameristiche di Annesley Black, giovane ed eccentrica autrice di Ottawa, Ontario che a quasi un decennio dal suo primo portrait album (No Use In a Centre, WERGO, 2013) approda ora trionfalmente alla prestigiosa etichetta austriaca Kairos.
La parola chiave, a volerne scegliere una per tutte, è invenzione: nel ciclo “tolerance stacks”, gli espliciti riferimenti a protagonisti ed elementi capitali della scienza e della tecnica sono, sì, dei meri pretesti, le scintille di un ben più sfrenato divampare performativo, ma sembrano alludere in maniera sineddotica al carattere comune a tutte le sue partiture: quella di inno perpetuo alla pura inventiva, sprezzante di ogni canonico stilismo eppure lucidissimo nel perseguimento delle sue imperscrutabili intenzioni espressive, senza con ciò sfociare in un ermetismo accademico a uso e consumo degli avanguardisti più intransigenti.
Un dominio formale elettromagnetico, quello foggiato da Black a propria misura, entro il quale persino le macchine possono finalmente esibire il loro distintivo timbro vocale, “umanizzarsi” nello spontaneo affiorare di gorgheggi inconsulti: è il tardivo riscatto – comune a molta altra ricerca contemporanea – del sentimento analogico, di un futuro anteriore rapidamente scavalcato dal freddo progresso digitale; tornano così alla ribalta, accanto a soprano e ensemble d’ordinanza, giradischi, nastri magnetici, sintetizzatori Moog e no-input mixer (espediente associato allo sperimentatore giapponese Toshimaru Nakamura), sino ai più oscuri oscillatori a codice Morse e ideogrammofoni, decani di un’improbabile orchestrina che non conosce tonalità ma può soltanto emularla tra nervosi contorcimenti di frequenze.
L’intero album si dà come una pantomima dell’assurdo senza lasciare alcun margine all’interpretazione. È tutto dinamica, scintillio di corpi sonori senza mèta che giunge al suo magnifico parossismo nelle suite per fiati: con “Not Thinking About the Elephants” (2018) e “industrial drive” (2010), rispettivamente per quartetto di sassofoni e di tromboni, i singoli strumenti sondano a tentoni la spazialità e la risonanza (nel primo caso anche artificiali) come se ascoltassero sé stessi per la prima volta, cercando con goffaggine un’armonia spontanea che, quand’anche si realizzasse, non può fare a meno di assumere risvolti farseschi e tragicomici.
Allo stesso modo il sibillino piano solo – e già il titolo ne tradisce l’essenza, “a piece that is a size that is recognised as not a size but a piece” (2013) – si rivela come null’altro che un gioco di specchi, un frenetico rincorrersi di figure dalle varianti minime e prossime all’aleatorietà, tasselli di un rompicapo percettivo che per venti snervanti minuti si fa ulteriori beffe della presunzione descrittiva.
Come si qualifica, allora, una musica che non è mai né questo né quello, ma sempre altro? Non ho trovato risposta che nella patafisica, la “scienza delle soluzioni immaginarie” di Alfred Jarry che come un terremoto sconquassò la drammaturgia teatrale tra Otto e Novecento, dando sfogo ai recessi più obliati (e spesso sconvenienti) del pensiero creativo. Con piglio altrettanto irriverente ma perfettamente controllato, le partiture di Annesley Black svegliano il cervello dalla passività dell’ascolto come pratica abitudinaria, solcando i sentieri del possibile in gioiosa autonomia estetica.