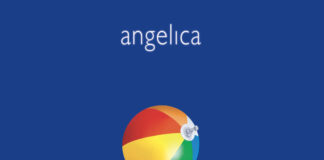Max Carbone nasce ad Ancona nel 1957. Dal 1961 vive a Merano, Alto Adige. Nel 1977 fonda Urbanoide, il suo primo quartetto, il genere è una sorta di punk jazz innervato di molta improvvisazione. Nel 1981 si iscrive all’università di Bologna; in quella città partecipa ad un seminario sull’improvvisazione con Andrea Centazzo e Lol Coxhill. Contemporaneamente fonda Funkwagen, un quintetto che elabora e sviluppa le tematiche del nucleo precedente. Con questo gruppo – che si scioglie nel 1986 – incide “il caso Funkwagen” per l’etichetta Rockgarage di Marco Pandin e distribuito da Materiali Sonori. Professionalmente lavora per quattro anni come tour manager di una agenzia di spettacoli e va in tour con Jaco Pastorius prima, Miroslav Vitous dopo e molti altri (Herbie Hancock, Art Blakey, Miles Davis). Negli anni Novanta prosegue la sua attività di bassista con diversi gruppi dell’area del nord Italia. Negli anni 2000, oltre a proseguire la sua attività musicale, fonda AlpsKlang, un festival dedicato alla musica della tradizione alpina declinata in chiave contemporanea, in attività per 8 anni. Dal 2010 al 2020 fonda e gestisce il collettivo d’improvvisazione thecomfortzone. L’esperienza recente è in trio con il chitarrista trentino Enrico Merlin e il batterista bolzanino Sandro Giudici con Miles Ahead, un progetto a cavallo tra il songbook elettrico di Davis e citazioni dal mondo del rock (Zappa, Bowie, King Crimson). Come direttore artistico progetta ur-klang, un progetto nuovamente dedicato alla musica improvvisata, nella cui prima edizione si è esibito un quartetto formato da Rossella Spinosa, Sofia Borges, Marcello Fera e Pierpaolo Martino.
L’ho intervistato in occasione della prima visione RAI del documentario dedicato proprio ad ur-klang (vedi qui il video del documentario per RAI Alto Adige che inizia dal 19’14” fino a 49’38”).
PM: Max vuoi parlarci del tuo rapporto con la musica e del tuo background?
MC: E’ stata per me la forma di espressione artistica più affine. Potevo applicare le pulsioni del corpo con maggiore efficacia. Il ritmo lo sento dentro, si scandisce automaticamente, senza sforzo; può avere uno sviluppo non canonico, mutare in continuazione, strappare una tela di un sistema strutturato, posso portarlo a me e reinventarlo. Le poche cose che ho imparato suonando standard jazz, in seguito, mi hanno aiutato a capire la forza dell’ensemble che lavora sincronicamente e ogni volta che portavo a casa un brano, lo terminavo, mi veniva una sorta di estasi, soprattutto perché mi sentivo parte di un miracolo, assumevo una identità precisa, ero il bassista. Fin da piccolo, mimavo di suonare il contrabbasso su un oggetto verticale, fosse un palo della luce piuttosto che una scopa, mi preparavo già allora. Ricordo il Cantagiro, che girava l’Italia negli anni sessanta, lo vedevamo a casa dei miei nonni a Fano, al mare. Ero stregato dalle chitarre elettriche, bellissime e lucenti, dal basso in particolare. Più grandicello, rimasi folgorato da Storia di un minuto della PFM, mi avvicinai alla chitarra, della quale suonavo solo le corde più basse, mimando il basso. In seguito, avevo un amico, formidabile chitarrista, che voleva a tutti i costi suonare con me. Che strumento suoneresti? Mi chiese. Da lì partì tutto.
PM: Cosa ti ha portato a scegliere il basso?
MC: Non ho studi accademici, sono autodidatta. Mi pareva che il bassista assumesse nei gruppi un ruolo autorevole, ma defilato, Mi sentivo così, avevo forza da esprimere, ma non ero da prima linea, niente strumenti solisti. Il suono, ovviamente, greve e potente, dalle vibrazioni così erotiche e assolute mi affascinava. E poi quella forma lunga e snella, le quattro corde vicine quasi all’essenzialità, capaci di un linguaggio forte e radicale. Poi, certo, i bassisti. Qui si aprirebbe un’altra storia, lunghissima; il punto di arrivo fu per me, come per molti, Jaco Pastorius, che ebbi la fortuna di conoscere personalmente e frequentare a lungo in due tournee che fece in Italia negli anni 80 come tour manager. Ma anche Miroslav Vitous, sempre in una breve tournée.
PM: Cosa rappresenta per te l’improvvisazione?
MC: Il piacere della scoperta, per dirla alla Quark. Non si tratta solo di vedere come reagisci tu alla situazione che si crea lì per lì, ma anche come reagiscono gli altri. Si deve partire attrezzati, consapevoli del percorso, irto di difficoltà, ma capace di darti molte sensazioni forti e significative. Ci sono modalità e modalità, linguaggi e sistemi precostituiti, come nelle improvvisazioni jazzistiche, dove, bene o male, fino a qualche tempo fa sembrava scaturire sempre lo stesso fluido espressivo; i giganti ti osservano da lassù – i nomi li sappiamo – e tu forse cerchi di pregarli nella loro stessa lingua. Altre situazioni portano altrove, anche parecchio lontano; in quei casi va osservato con attenzione il processo che si crea, i linguaggi di formazione singola che confluiscono nel flusso e cosa nasce. Se si arriva ad armonizzarsi, a dialogare senza prevaricazioni e lontani dai luoghi comuni, se nasce quasi una…. canzone, qualcosa che entra nell’orecchio senza violentarlo e non ti rimanda a nulla di preciso, ecco che accade qualcosa.
PM: Come nasce il progetto UR-KLANG?
MC: Perché ho praticato l’improvvisazione per oltre un decennio – dopo progetti rock, jazz, ethno e ibridi vari – e ho, abbiamo, raggiunto dei buoni risultati, solo localmente. Poi c’è la componente politica, oggi dismessa e infilata nel cassetto a marcire, che per me significò molto. La funzione sociale della musica, i suoi portati politici – in termini di obiettivi, anche stilistici – sono stati per me sempre importanti; certo i neri su tutti, ma anche i nostri indimenticati Area. La musica è una forma di vita sociale. ur-klang risponde a questa domanda: si può generare un suono organizzato, coerente, riconoscibile dall’interazione on-stage di musicisti provenienti da formazioni diverse, accademiche e non? E’ possibile, oppure è una inutile velleità? Le forme sono rigide, se rappresentano scuole; chi le apporta è capace di non farle deflagrare reciprocamente, cercando di avere il sopravvento sull’altro? Vi sono elementi basici – ritmo, melodia, armonia – che possono fungere da elementi di costruzione di una lingua comune, seppure temporanea. Si disegna un arcipelago nel quale le isole sono arrivate ad essere prossime e generano… suono organizzato oppure no?
PM: Come è andata secondo te l’evento del 22 aprile 2023 a Merano?
MC: La parte contenutistica del progetto e la sua originalità ha creato qualche difficoltà, diciamo, di approccio da parte dell’ente pubblico, che ha faticato a capire l’innovatività di ur-klang; insomma, un prodotto reputato eccessivamente di nicchia che, per essere sostenuto nella sua parte completa, produce dei costi reputati non giustificati se messi in relazione con altri tipi di eventi. Non commento. Detto ciò, anche grazie alla buona reazione di pubblico e di critica sto pensando che vale la pena rilanciare puntando proprio sul quartetto, un nucleo che si è mostrato, sorprendentemente ma neanche tanto, affiatato e che ha prodotto un’ottima performance. L’idea è dunque quella di tenere aperto il laboratorio ur-klang, magari inserendo anche me stesso al basso elettrico, progettando – proprio come tu mi hai suggerito – un duo che si innesta nel quartetto, oppure raggiungere la dimensione del quintetto. Vedremo.
 PM: Quindi UR-KLANG potrebbe dare origine a nuove idee…
PM: Quindi UR-KLANG potrebbe dare origine a nuove idee…
MC: Organizzativamente e artisticamente direi di sì. Vi è stata delicatezza nell’approccio del quartetto, dialogo e ascolto reciproco vi sono stati. Non dimentichiamo che il format prevede che i musicisti non provino affatto prima del set, ma che potranno solo organizzarsi parlandosi, ma nulla di più; arriveranno a freddo sul palco e da lì incomincerà il viaggio; né loro né chi ascolta sa dove si andrà a finire. In futuro sarà ancora più rischioso, perché se quest’anno per diverse ragioni, ho dovuto organizzare io il quartetto – Spinosa, Fera, Martino e Borges – nell’edizione di ottobre, se riuscirò a farla, i musicisti formeranno dei gruppi – duo, trio, quartetto, quintetto, piccolo ensemble – sulla base di un’estrazione a sorte. Una due giorni di ricerca, laboratorio, musica, discussioni, verifiche e, certo, potenziali fallimenti, ma questo sta nelle cose.
PM: Ti ringrazio per avermi coinvolto nel progetto; potresti parlarci della scelta degli altri musicisti e della loro identità sonora?
MC: Marcello Fera ha formazione classica, è compositore e direttore e da lunghi anni vive a Merano producendo ottimi progetti, tra i quali il suo Sonora, un festival sempre molto stimolante e innovativo. Rossella Spinosa, pianista e docente di conservatorio, pur riluttante, si è poi data disponibile e il suo apporto è davvero stato decisivo, per lei l’improvvisazione è un po’ come l’incontro con l’alieno, ma non si è spaventata. Sofia Borges è una musicista formidabile, costantemente impegnata in progetti aperti e innovativi e ha apportato a ur-klang una percussività e un suono di grande livello tecnico e inventivo.
PM: E’ andato da pochissimo in onda su RAI Alto Adige il documentario “UR-Klang. Echi di improvvisazione in Alto Adige”. Credo che Armin e la sua troupe abbiano fatto un ottimo lavoro- Che ne pensi?
MC: Davvero, l’intesa è stata immediata e la loro professionalità indiscussa ha fatto il resto; si sono innestati nel progetto come ulteriore elemento produttivo e creativo.
PM: Hai altri progetti in cantiere Max ?
MC: Oltre ad una possibile apertura di ur-klang anche con il mio apporto, spero che ritorni on stage il trio con Enrico Merlin e Sandro Giudici, il Miles Ahead trio, del quale mi onoro di essere il bassista. Poi vorrei realizzare un album con il progetto thecomfortzone, anch’esso dedicato alla musica improvvisata, con i mei compagni di sempre.